Dizionario del Tempo del Virus R-Z
A
ALIENO
ALLENAMENTO
AMBIENTE
AMUCHINA
ANTICORPI
Antologia di Spoon River (Lee Master)
ANZIANI
Armi, acciaio e malattie, Diamond
Aspettando Godot (Beckett)
ASSEMBRAMENTI
ATTESA
AULE VUOTE
AUTOCERTIFICAZIONE
B
BALCONE
BARBIANA
BELLEZZA
BELLA CIAO
(S)CONFINATA
BOLLETTINO DI GUERRA
BRICOLAGE
C
Camera verde (Truffaut)
CAMMINARE
CAOS (NUOVA TEORIA)
CATTIVITA’
Cielo in una stanza (Paoli)
Città verrà distrutta all’alba (Romero)
CLAUSTROFOBIA
CLAUSURA
COMPLOTTISMO
COMPLOTTISMO: UNA POSTILLA
COMPLOTTISMO: TEORIE DEL COMPLOTTO I
COMUNICAZIONE MEDICO-SCIENTIFICA
Condannato a morte è fuggito (Bresson)
CONNESSIONI
CONFERENZA STAMPA
CONFINE
CONFINO
CONTABILITA’
CONTAGIO
Contagion, Soderbergh
CONTATTO
CONVERSIONE
COPRIFUOCO
CORONABOND
COVID-19
COVIDIOTA
D
Decamerone (Boccaccio)
Dei Sepolcri (Foscolo)
DEMOCRAZIA
DENTRO/FUORI
Deserto dei Tartari (Buzzati)
DIALOGO
Diario dell’alloggio segreto (Frank)
Diario dell’anno della peste (Defoe)
Diceria dell’untore (Bufalino)
DIDATTICA A DISTANZA
DIRITTO ALLA SALUTE
DISEASE X
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Dissipatio H.G. (Morselli)
DISTACCO
DISTANZE
DISTANZIAMENTO
DPCM
Dottor Semmelweis (Celine)
DRESS CODE
DRESS CODE PUBBLICITA‘
DUECENTO METRI
E
EPIDEMIA
EROE
F
FALSE NOTIZIE
FAME
FANTASMA
FARE LA CODA
Festino nel tempo della peste (Puskin, Kiuj)
Finestra sul cortile (Woolrich, Hitchcock)
FOCOLAIO
FOSSE COMUNI
FRAGILITA’
FRONTIERE EUROPEE
FUNERALE
FUTURO
G
Game Changer (Bansky)
GATTO
GIORNI
Giorno dei trifidi (Wyndham)
GUERRA
Guerra dei mondi (Wells)
Guerra del Peloponneso (Tucidide)
H
I
IMMOBILITA’
IMMUNIZZAZIONE
IMPRESA
Inferno, Comedia (Dante)
INFORMAZIONE
INTIMITA’
INVISIBILITA’
IO QUINDICENNE STUDENTESSA ON LINE
IO UNDICENNE RECLUSO DOMESTICO
IRRESPONSABILI
ISOLAMENTO
L
Lacrime amare di Petra von Kant (Fassbinder)
LAVAGGIO DELLE MANI RITUALE
LAVARSI LE MANI
LAZZARETTO
LEGGINS
Lentezza (Kundera)
LIBERTA’
Libro contro la morte (Canetti)
LIMITE
LOCKDOWN
M
MALATTIA
Maschera della morte rossa (Poe)
MASCHERINA
MEDICO DI FAMIGLIA
METAFORE DI GUERRA
MITIGAZIONE
MONDO
MONDI PARALLELI
MORIRE
MUSICA VIRTUALE
N
NASCONDERSI
NATURA
NEGAZIONE
NEMICO
Noè (Recherche, Proust)
NOI QUINDICENNI E LA PAURA
NON CREDO
NON MOLLARE
NONNI
NOSTALGIA
O
OLFATTO
OMS
ORA D’ARIA
ORDINANZA
P
PARLAMENTO
PAROLA
PARTENZE
PASSEGGIATA
Passeggiata (Walser)
PASSEGGIATA CON IL CANE
PAURA
PAZIENTE ZERO
PAZIENZA
PERIFERIA
Peste (Camus)
Peste bruna è passata di là (la), Guerin
Pestifero e contagioso morbo (Cipolla)
PICCO
PIPISTRELLO
POESIA
PREGHIERA
PRIMA LINEA
PRIMAVERA
PRIVACY
PROUST
PROVINCIA
PROVVEDIMENTI CONCORRENTI
PUBBLICITA’
PULVISCOLO COMUNICATIVO
Q
R
Ragazza col timpano perforato (Bansky)
RECLUSIONE
RELIGIONE
REPULSION (Polanski)
RESILIENZA
RIVINCITA
RUNNER
S
SALUTE ISTITUZIONALE
SARS-Cov-2
Scritti sui terremoti (Kampf)
SEGNALATORI DI INCENDIO
SELVATICO
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
SESSO
SILENZIO
SMARRIMENTO
SMART WORKING
SOLITUDINE
SONNAMBULISMO
SPAGNOLA
SPAGNOLA, MEMORIA
SPESA
SPIRITUALITA’
Stanza tutta per sè (Woolf)
STARE A CASA
STATO
STATISTICHE
STATO DI EMERGENZA
STORIA ON LINE
Stronzate (Frankfurt)
SUPERMERCATO
T
TALK SHOW
TAVOLO
TAMPONE
TEMPO
TENDENZE SECURITARIE
TERAPIA INTENSIVA
TESTIMONI SCOMPARSI
TRACKING COVID-19
TRIAGE
TUTA
TUTTO ANDRA’ BENE
U
V
VELOCITA’
VACCINO
VIAGGIO
Viaggio intorno alla mia camera (de Maistre)
VIRULENZA
Volto e il vaiolo (Pascal)
VULNERABILITA
Z
Ragazza col timpano perforato
Bansky, 2014
di Moira Sbravati, funzionario pubblico
Il writer inglese noto solo per il suo nome d’arte Bansky, esponente di spicco della street art (o post graffiti o guerrilla art), nell’ottobre del 2014 decise di rivisitare la tela di Vermeer Meisje met de parel (Ragazza con orecchino di perla), celebrata nell’omonimo romanzo di Tracy Chevalier, pubblicato nel 1999. Basky diede la sua versione del piccolo quadro sulla parete di uno studio di registrazione nella zona portuale di Bristol, sua città natale, riproponendo l’enigma di quella fanciulla dallo sguardo profondo, potente e immediato, così come immediata e potente è la cifra comunicativa delle sue figure, testimoni silenti delle storture irrisolte del mondo. Il titolo dell’opera Girl with the pierced eardrum (La ragazza col timpano perforato) era stato ispirato dalla presenza sull’ampia parete di in allarme del sistema di sicurezza ADT, che nella versione Bansky si sostituiva all’orecchino di perla del modello


Nel 1966, Giuseppe Ungaretti dedicò uno scritto di grande acume all’opera di Vermeer, dove si incontra questa osservazione: “In Vermeer le figure non hanno né pretendono di avere maestà. Sono persone che per abitudine non escono da quei limiti prefissi a un viver di medio ceto, e, tutt’al più, potrebbero arrivare ad eleggersi quei limiti ambiti da chi sia molto semplice in tutto, e lo sia quindi anche nel sentire e nell’immaginare. Ciò non toglie nulla alla profondità, può dare anzi all’espressione una giusta profondità, la giusta misura della profondità, quella misura che è indispensabile aiuto al raggiungimento di un vero che non superi le misure della persona umana, che anzi si trovi, nei limiti stessi della persona umana, presente, ad affermare l’indeterminatezza della poesia persuadendola ad emergere”. Per una sorta di curiosa consonanza, queste parole dedicate all’opera di Vermeer, potrebbero essere pensate anche anche per descrivere la pienezza dei profili dei bambini, degli uomini e degli animali creati da Bansky.
Nella notte tra il 21 e il 22 aprile 2020, La ragazza col timpano perforato è stata attualizzata. Un’enorme mascherina chirurgica, tecnicamente conosciuta come FFP1, ancorata con dei cavi metallici nottetempo, probabilmente dallo stesso autore, s’impone alla nostra attenzione con tutta la forza del gesto artistico e ci interroga sulla pervasività e i paradossi della pandemia di COVID-19, che ha costretto Bansky e i sudditi britannici a confinarsi nelle proprie abitazioni.

Verso metà aprile, cinque fotografie postata sul profilo Istagram dell’artista, ci hanno mostrato un’altra opera del periodo del confinamento, intitolata My wife hates it when I work from home (Mia moglie odia quando lavoro da casa). Se la pandemia ha reso impraticabile la street art, la creatività dell’artista ha eletto a spazio ideale la propria abitazione, in questo caso il bagno, scelto non a caso come il luogo privilegiato nel quale, nella quarantena, molti ritrovano la propria privacy. I famosi ratti di Bansky corrono lungo le pareti, giocano con gli oggetti, sovvertono l’ordine delle cose: lo specchio è inclinato, la carta igienica srotolata, la pasta dentifricia spruzzata sulla parete… una delle bestiole imbratta con la propria orina l’asse del water, un’altra è colta nel momento in cui sta facendo cadere a terra il dispenser del sapone e, riflessa nello specchio, una terza indica un contatore di giorni. Se il bagno di casa diventa metafora del mondo, il sopravvento del caos sull’ordine diviene il simbolo della perdita di controllo della nostra società, distratta e immemore della propria fragilità, sulla realtà.
“Nella storia dell’umanità i casi di peste e di guerra sono stati tanti. Eppure ogni volta l’umanità si è lasciata trovare impreparata dalla guerra o dalla peste”, osservava Albert Camus nel suo romanzo La peste, pubblicato nel 1947. Davanti a questi di Bansky, come non pensare ai ratti descritti da Camus.

Roncoferraro, 2 maggio 2020
Bibliografia. Giuseppe Ungaretti, “Invenzione della pittura oggi” in L’opera completa di Vermeer, Rizzoli, Milano, 1967; Tracy Chevalier, La ragazza con l’orecchino di perla, Neri Pozza, Vicenza, 2000; Albert Camus, La Peste, Bompiani, Milano, 2017.
RELIGIONE
di Paola Marini, storica dell’arte e museologa
Le epidemie sono state per secoli, nel mondo occidentale, legate inscindibilmente alla religione, in quanto minacciate o anche semplicemente avvertite come castighi divini, e pertanto da curare innanzitutto con la fede. Insieme alla letteratura, lo testimonia la presenza, al centro dei lazzaretti, di un altare, visibile da ogni punto del recinto, secondo una prospettiva che Michel Foucault avrebbe ribaltato nel suo panopticon. In una Venezia cristallina come una veduta di Canaletto, due sublimi tesori dell’umanità stanno a ricordarci questo ‘naturale’ rapporto: la chiesa del Redentore, alla Giudecca, costruita da Andrea Palladio per celebrare la fine della peste del 1575, fine ancora oggi ricordata da una delle feste popolari più amate della città e la chiesa della Madonna della Salute, a Dorsoduro, eretta da Baldassarre Longhena in adempimento del voto fatto per la cessazione della pestilenza manzoniana del 1630, e il cui culto è altrettanto vivo. Lo stesso dicasi per la diffusione delle immagini dei santi taumaturghi, in particolare Sebastiano e Rocco.

Se ancora durante l’influenza spagnola si svilupparono movimenti spiritualistici, quello del Covid-19 è il primo caso nella storia in cui la religione cede decisamente il campo alla scienza per divenire pratica essenzialmente individuale. Sospese le celebrazioni pubbliche di messe, matrimoni, battesimi e funerali, è quest’ultima mancanza che pare colpire più delle precedenti la società, privata di un momento di commiato e compartecipazione del dolore. Pochissime sono le trasgressioni. Come ovunque anche nella chiesa si incrementa l’uso delle tecnologie digitali per mantenere il contatto con i fedeli, anche se centoventi sacerdoti morti, e non tutti anziani, stanno a significare che il clero non si è sottratto ad un impegno di prima linea nei confronti della comunità. Le chiese rimangono aperte, eppure sostanzialmente vuote. Ma è il televisore che diviene, secondo un esplicito incoraggiamento della gerarchia ecclesiastica, un altare domestico attraverso cui assistere soprattutto alla messa. Dallo schermo televisivo sono entrate nelle case le immagini del solitario pellegrinaggio urbano di papa Francesco, che cammina lungo via del Corso il 15 marzo, per recarsi da Santa Maria Maggiore, dopo aver reso omaggio all’immagine venerata di Maria salus populi romani, a San Marcello, dove è custodito il crocifisso che nel 1522 venne portato in processione per invocare la fine della peste.

Proprio a confronto degli imponenti riti collettivi allestiti nella storia in queste circostanze, nonché dell’affollato incontro di ogni domenica con i fedeli, risalta ancor più la solitudine del pontefice in una piazza San Pietro deserta nella preghiera di intercessione del 27 marzo (in cui, sia detto per inciso, il crocifisso appena citato ha sofferto della permanenza all’aperto, ed ha dovuto essere prontamente avviato al restauro) e del giorno di Pasqua. Il colonnato costruito da Bernini per abbracciare simbolicamente il mondo intero fa da cornice ad un pontefice che con pacata fermezza pronuncia parole di condivisione e di speranza in assoluto isolamento. Un’immagine tanto sorprendente quanto indimenticabile.
I riti della Pasqua di Ebrei ed Ortodossi subiscono, a distanza di pochi giorni, le medesime restrizioni, così come il Ramadan iniziato il 23 aprile. Anche nella cosiddetta fase 2 il protrarsi del divieto delle celebrazioni che suscita la vibrata protesta dei vescovi della CEI, è prontamente stemperata dalla reazione di papa Bergoglio: “Preghiamo il Signore perché dia al suo popola la grazia della prudenza e dell’obbedienza alle disposizioni perché la pandemia non torni”. Liberata dalla ‘responsabilità’ del contagio e da attese salvifiche la Chiesa torna, come alle sue origini, ad essere una scelta intima e profonda.
Verona, 1 maggio 2020
RIVINCITA
di Carlo Benfatti, storico e folklorista
Smog che si dirada, polveri sottili, sempre meno percepibili, traffico alleggerito, acque dei fiumi che tornano verde-azzurre, erba e vegetazione che invadono ovunque, apparizione di fiori scomparsi da tempo, ecco il risultato del lockdown imposto alla nostra società dal coronavirus. La natura prende il sopravvento e si riappropria dei suoi spazi. Così anche gli animali che fino a qualche mese fa stavano ritirati nelle loro tane fuggendo l’uomo, ora escono indisturbati “passeggiando” in luoghi da cui prima erano severamente tenuti lontano. Proprio in una di queste sere alla TV si sono visti capre, cinghiali, volpi e altre specie camminare per le strade o gironzolare attorno ai cassonetti in cerca di cibo… Non c’è da meravigliarsi che alcune varietà di vertebrati o invertebrati ritenute estinte, ora riemergono alla vita come “resuscitate”.
Tutti queste novità che fanno rivivere il paesaggio naturale sono certamente benvenute e apprezzate, però a che prezzo? C’è voluta un’epidemia con provocazione di malati, ricoveri in strutture sanitarie, perfino tanti decessi, e con crisi economico-sociali, per restituire alla natura ciò che la civiltà tecnologica-industriale le ha sottratto? Non sono bastati i movimenti ecologisti in tutto il mondo e l’appassionata presenza di Greta Thumberg che ha viaggiato dappertutto esortando capi di stato, scienziati, personalità di ogni settore a rispettare di più la natura, il nostro pianeta? L’abbiamo vista perfino piangere disperata per convincere i potenti della terra a prendere finalmente giusti provvedimenti per invertire la rotta. Li ha quasi implorati perché fermassero il riscaldamento globale, causa della desertificazione e degli eventi meteorologici estremi. Li ha più volte scongiurati di volgere l’attenzione alla flora e alla fauna sulla strada della scomparsa.
Non è bastata l’enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco a lanciare il pericolo cui va incontro l’umanità perseguendo lo sfruttamento incondizionato delle risorse, fra l’altro togliendo spazio verde e fonti alimentari a popoli che in alcune parti del mondo sono abituati da generazioni a vivere in perfetto equilibrio e armonia con l’ambiente? Di certo il limite cui oggi siamo giunti, vale a dire quello dell’abuso, dello sfruttamento delle risorse naturali, siano esse vegetali, animali che paesaggistiche, non è più valicabile.
A questo punto c’è un campanello d’allarme: la ribellione della natura. Essa attacca l’umanità nel punto in cui è più sensibile e di cui va orgogliosa: la sopravvivenza, la trasmissione della progenie, lo sviluppo progressivo delle proprie attività. Un esempio che tutti possono constatare. Quando si vedono ovunque coltivazioni intensive che negano ogni metro di terra alla vegetazione spontanea con erbe e fiori autoctoni, quando si scoprono allevamenti di animali costretti in luoghi angusti e malsani e alimentati con mangimi miscelati a prodotti chimici che affrettano l’ingrasso, allora è il momento che la vita biologica si ribella dato che viene conculcata, abusata, modificata fino all’eccesso.
Proprio in questa situazione di estrema costrizione della vita botanica e zoologica per il profitto, non dobbiamo stupirci se compaiono dei virus deleteri che fuoriescono dagli animali, specie da quelli selvatici, fino a quel momento rimasti sotto traccia e quindi ben circoscritti, per giungere fino all’uomo completamente privo di anticorpi. Si tratta della rottura di un equilibrio collaudato da millenni, forse da milioni di anni, quando è comparsa la vita su questo pianeta. Il virus di Covid-19, responsabile dell’attuale pandemia, è uno dei più pericolosi, forse è sempre stato presente nella vita biologica degli animali domestici e di quelli allo stato brado, e fin che è esistita la stabilità di cui si diceva prima, esso è rimasto intrappolato e tenuto sotto controllo dagli anticorpi dei medesimi animali.
Una volta infranto l’equilibrio, questo virus particolarmente aggressivo e mutevole si è trasferito su altri esseri, specie quelli umani, provocando in quest’ultimi la tragedia che tutti stiamo vivendo. Ha ragione la virologa Ilaria Capua dell’Istituto di ricerca dell’Università della Florida la quale, intervistata dalla TV italiana, ha detto che il coronavirus proviene dal mondo animale e non dalla manipolazione effettuata in qualche laboratorio del mondo, come alcuni hanno insinuato. I virus provengono dalla natura e quando viene meno quell’armonia a lei congeniale, fra l’altro costituitasi da tempo immemorabile, tutto viene sconvolto. La natura, alla fine, si ribella e procede secondo i suoi dettami. Si ribella o, meglio, si riprende la rivincita.
Mantova, 23 aprile 2020
Bibliografia. Papa Francesco, Laudato si’. Sulla cura della casa comune, Libreria Editrice Vaticana, Roma, 2015.
RUNNER
di Achille Saletti, criminologo e Presidente dell’Associazione Saman
Runner: corridore, podista. In realtà, in tempi di corona virus, questa figura del tutto innocua quanto diffusa nelle campagne, parchi e strade cittadine assume, suo malgrado, una dimensione del tutto e per tutto assimilabile a quella dell’untore di manzoniana memoria.
Accade che il lockdown adottato dal Governo italiano in tutto il paese, nelle pieghe del primo decreto del 9 marzo decreto che lo impone lasci enormi varchi in merito alle attività che il cittadino può svolgere all’interno del rispetto delle distanze individuali e sociali. Il popolo italiano, riunitosi sui balconi a cantare e ballare intonando inni alla patria nel giro di pochi giorni realizza che tali attività canore rischiano di ferire la sensibilità del numero crescente di famiglie in lutto per la morte dei propri cari.
Tale scoperta impone la fine dei canti ma non la permanenza del popolo sui balconi. Tra le tante attività a cui si dedicano i cittadini in cattività si annovera, prioritaria, la denuncia del runner, che nell’immaginario collettivo diventa la vera causa della curva ascendente dei contagi. Pur correndo in perfetta solitudine e in assenza di dati scientifici che possano fare temere una specifica pericolosità, il runner cattura l’odio di una popolazione incattivita a causa di severe restrizioni che impongono solo brevissime sortite al supermercato. La paura della pandemia crea le perfette condizioni per la affermazione della teoria del capro espiatorio.

Il runner diventa quella figura a cui è attribuita tutta la responsabilità di un evento negativo che non si riesce a fermare e ne deve subire le conseguenze con forme di palese ostracismo, maledizioni , gogna social fino alla minaccia fisica e non solo.In data 19 aprile nella città di Padova un runner viene rincorso e picchiato da due suoi concittadini. Il runner come soggetto da odiare soppianta, durante questo tempo sospeso, lo stesso immigrato che dopo il venire meno degli eroinomani, aveva sostituito in molti italiani la causa responsabile del declino dell’intero paese. In tal senso la sua figura e lontana parente dell’untore manzoniano. ma se nella peste del 600, la figura dell’untore quale capro espiatorio rievocava, in termini biblici la necessità di emendarsi dalle punizioni divine, in tempi moderni l’approccio sociologico ci suggerisce di individuare nel caproespiatorio, una dinamica di massa tesa a esorcizzare la propria impotenza o colpa su un terzo o su una categoria
Milano, 20 aprile 2020
SALUTE ISTITUZIONALE
di Massimo Ferro, senatore della Repubblica
E’ molto strano, e quasi impossibile, in questo contesto, essere un parlamentare della Repubblica al cento per cento, pienamente operativo. Il Parlamento, il Senato, in particolare, lavora oggettivamente a ranghi ridotti per la difficoltà di garantire contestualmente la presenza di tutti i Senatori (315, più i senatori a vita) rispettando le distanze tra le persone imposte dai decreti in vigore per fronteggiare l’epidemia.
E’ giusto riconoscere che il Senato non è oggi in grado di garantire un efficace lavoro parlamentare da remoto: per l’impreparazione dei senatori, sorpresi come tutti da una situazione assolutamente imprevista; ma anche degli stessi sistemi informatici di votazione. Per garantire al’assemblea la sua fondamentale funzione legislativa, le forze politiche hanno concordato di ridurre in proporzione il numero dei senatori presenti in aule per le discussioni e il voto, adattando il regolamento a questa situazione di emergenza sanitaria. Va ricordato che il Senato non rimase chiuso nemmeno durante lo scoppio della prima guerra mondiale: la democrazia non è e non può andare in quarantena nemmeno questa volta.

Ma non è solo sanitaria, l’emergenza. E’ lo stato di salute politica del nostro sistema nel complesso che sta soffrendo gravemente. In un periodo come l’attuale, dove si avverte fortissimo il sentimento di “antipolitica” diffuso nel Paese per l’attuale “casta”, vale la pena ricordare alcuni punti fermi. Primo: la selezione della classe politica passa dai partiti e o dai movimenti, come prescrive l’art. 49 della Costituzione. Secondo: pochi,e quasi sempre non i migliori, si dedicano e si impegnano nei partiti e o nei movimenti e negli organismi di rappresentanza (lo ha sottolineato, ad esempio, Zygmunt Bauman ne La società individualizzata). Terzo: in politica e nei sistemi di rappresentanza lo spazio viene comunque occupato, non rimane vuoto, a disposizione, in attesa di qualcuno che stia pensando se occuparlo o meno. Quarto: Il nostro tempo è caratterizzato da una generalizzata decadenza valoriale in tutti i campi e in tutti i settori: non emergono sempre i migliori. I sistemi di rappresentanza, perciò, sono in crisi, non essendo alimentati da risorse umane adeguate alle responsabilità e ai problemi da affrontare. E’ una situazione che non investe solo le istituzioni politiche, ma anche tanti altri settori professionali, scientifici, accademici, financo ecclesiastici.
C’è, in poche parole, una carenza di rappresentatività in chi è oggi rappresentante. Questo perché i migliori non scendono in campo, rimangono in tribuna e, quando va bene, si limitano a fornire saggi consigli. Questo non è accettabile. Oggi in particolare in presenza di questo smarrimento collettivo, chi ha idee, capacità, talento e voglia di fare dovrebbe scendere nell’agone. Se il corona virus riuscisse, tra i molti disastri che sta provocando, a mobilitare e scuotere le coscienze dei migliori avrebbe almeno un piccolissimo merito: quello di aver contribuito indirettamente a porre basi solide e profonde alla rinascita, che comunque ci sarà. La democrazia, la nostra democrazia non è e non può andare in quarantena. La nostra democrazia, nuovamente alimentata da energie e competenze qualificate, potrebbe dare un contributo decisivo al necessario rinascimento.
Verona, 29 marzo 2020.
SARS-CoV-2
di Stefano Adami, microbiologo GSK Vaccins
La malattia respiratoria denominata “COVID-19” (“CO” sta per corona, “VI” per virus, “D” per disease e “19” per anno 2019) è stata segnalata per la prima volta alla fine del 2019 a Wuhan, in Cina, e ora si sta ampiamente diffondendo in tutto il mondo (pandemia).
La COVID-19 si trasmette principalmente da persona a persona, attraverso le goccioline disperse nell’aria con la tosse o gli starnuti da un soggetto infetto. L’infezione si può contrarre anche toccando superfici su cui è presente il virus e poi toccandosi la bocca, il naso o gli occhi.
La malattia é causata da un nuovo Coronavirus, denominato SARS-CoV-2, che fa parte della stessa famiglia dei virus della SARS (Sindrome Respiratoria Acuta Grave), a cui é strettamente collegato ma diverso. Il gruppo di scienziati incaricati di studiare il nuovo ceppo di Coronavirus ritengono che sia “fratello” di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.
I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus, identificati a metà degli anni ’60 del secolo scorso e sono noti per infettare l’uomo ed alcuni animali (inclusi uccelli e mammiferi). Esistono almeno 7 tipi di coronavirus che provocano malattie negli esseri umani. Si tratta di malattie respiratorie che variano per gravità: da infezioni lievi delle vie aeree superiori, i cui sintomi sono quelli del comune raffreddore, a quelle molto più gravi e in alcuni casi letali che hanno recentemente causato importanti epidemie di polmonite come la MERS (Sindrome respiratoria mediorientale, identificata nel 2012) e la SARS (Sindrome respiratoria acuta grave,identificata nel 2002) e l’attuale COVID-19 .
La comparsa di questi nuovi virus patogeni per l’uomo, precedentemente circolanti solo nel mondo animale, è un fenomeno ampiamente conosciuto (chiamato spill over o salto di specie) e si ritiene che possa essere alla base anche dell’origine del SARS-CoV-2. Al momento la comunità scientifica sta cercando di identificare la fonte dell’infezione.
I Coronavirus hanno una morfologia rotondeggiante e dimensioni di 100-150 nm (nanometri) di diametro (circa 600 volte più piccolo del diametro di un capello umano).
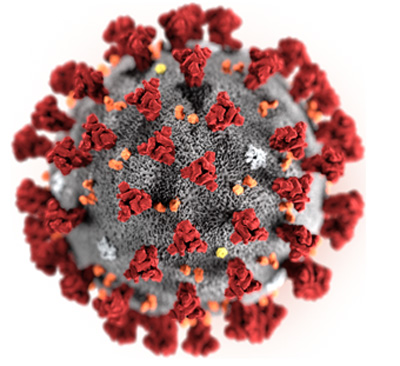
L’illustrazione creata dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC) statunitense, rivela la morfologia ultrastrutturale del SARS-CoV-2. È possibile notare sulla superficie le glicoproteine S (in rosso) che decorano la superficie esterna del virus, conferendogli l’aspetto di una corona (da cui il nome).
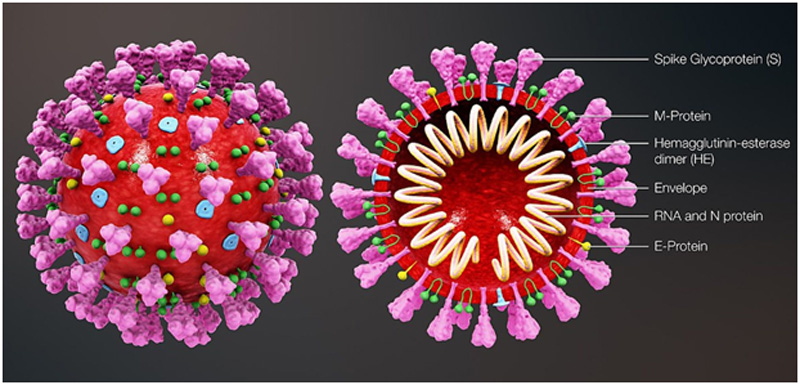
In riferimento alla immagine soprastante, partendo dallo strato più esterno e procedendo via via verso l’interno del virus, è possibile notare diverse componenti:
• Glicoproteina S (“spike”): il virus mostra delle proiezioni sulla propria superficie, della lunghezza di circa 20 nm. Tali proiezioni sono formate dalla glicoproteina S (“spike”, dall’inglese “punta”, “spuntone”). Tre glicoproteine S unite compongono un trimero; i trimeri di questa proteina formano le strutture che, nel loro insieme, somigliano a una corona che circonda il virione. Le differenze principali di questo nuovo Coronavirus rispetto al virus della SARS sembrano essere localizzate proprio in questa proteina spike. La glicoproteina S è quella che determina la specificità del virus per le cellule epiteliali del tratto respiratorio: il modello 3D infatti suggerisce che SARS-CoV-2 sia in grado di legare il recettore ACE2 (angiotensin converting enzyme 2), espresso dalle cellule dei capillari dei polmoni.
• Proteina M: la proteina di membrana (M) attraversa il rivestimento (envelope) interagendo all’interno del virione con il complesso RNA-proteina
• Dimero emagglutinina-esterasi (HE): questa proteina del rivestimento, più piccola della glicoproteina S, svolge una funzione importante durante la fase di rilascio del virus all’interno della cellula ospite
• Proteina E: l’espressione di questa proteina aiuta la glicoproteina S (e quindi il virus) ad attaccarsi alla membrana della cellula bersaglio
• Envelope: è il rivestimento del virus, costituito da una membrana che il virus “eredita” dalla cellula ospite dopo averla infettata
• RNA e proteina N: il genoma dei Coronavirus è costituito da un singolo filamento di RNA a polarità positiva di grande taglia (da 27 a 32 kb nei diversi virus); non sono noti virus a RNA di taglia maggiore. L’RNA dà origine a 7 proteine virali ed è associato alla proteina N, che ne aumenta la stabilità.
Siena, 29 marzo 2020
Riferimenti. Le informazioni sono tratte dal sito dell’Universita Vita e Salute San Raffaele di MIlano
SEGNALATORI DI INCENDIO
di Carlo Saletti, storico e regista teatrale
Del disastro planetario di questi mesi, il più grave dopo la seconda guerra mondiale, il primo dato che balza agli occhi è l’incapacità di anticipare, da parte delle nostre società complesse, eventi che conducono a crisi sistemiche potenzialmente catastrofiche – elemento sbalorditivo, se solo si pensa al ruolo che i modelli predittivi occupano negli ambiti ambiti più diversi (scienza politica e scienze attuariali, marketing, meteorologia, ecc.). Lo enuncia in un video del 17 marzo come punto preliminare ad una riflessione sulla pandemia, che stiamo vivendo, Aurélien Barrau, astrofisico francese ed esponente di punta della collapsologia, scienza che studia i rischi del crollo della nostra civiltà.
La certezza della stabilità dell’ecosistema globale, condivisa dalle leadership e dalle opinioni pubbliche, ha avuto ripercussioni drammatiche nella risposta all’attuale crisi sanitaria (il precoce esaurimento dei dispositivi di protezione individuale, componente basilare per la vita quotidiana in tempi di epidemia, ne è l’esempio più significativo). Eppure le voci che in questi anni hanno messo sull’avviso che la nostra casa comune è instabile non sono mancate. Provengono dall’ambito della ricerca medica e da quella storica, dal mondo dall’ambientalismo, dalla divulgazione scientifica, da influenti personalità. Invitato nel 2015 a tenere l’annuale TED Talk, Bill Gates intitolò il proprio intervento “The next outbreak? We’re not ready”. L’epidemia di Ebola, che l’anno precedente aveva colpito diversi paesi dell’Africa subsahariana, lo aveva spinto a sensibilizzare gli ascoltatori sul rischio di un contagio globale: “Se qualcosa ucciderà 10 milioni di persone, nei prossimi decenni”, osservò, “è molto più probabile che sia un virus altamente contagioso piuttosto che una guerra… Non missili, ma microbi”. L’idea che possa essere un virus a ferire seriamente l’umanità circola da anni. L’epidemiologo Donald S. Burke indicò, nel corso di una conferenza tenuta nel 1997, nella famiglia dei coronavirus una seria minaccia alla salute pubblica, trattandosi “di virus con alta capacità evolutiva e provata abilita nel causare epidemie nelle popolazioni animali”.
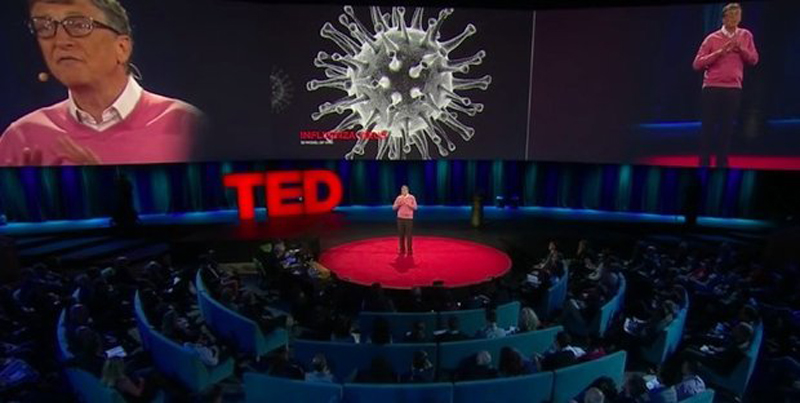
Simili premonizioni hanno valicato i confini delle riviste specializzate e dei simposi. Le si trova esposte in diverse opere di divulgazione che hanno descritto gli effetti devastanti sulla salute pubblica e sul sistema sanitario di una probabile epidemia. I giornalisti scientifici James Howard Kunstler e David Quammen, noti entrambi ai lettori italiani, sono tra costoro. “Per poter diffondere il contagio il virus non necessita d’altro che di vaste popolazioni cosmopolite”, ribadisce Kunstler, ricordando che “laddove le popolazioni umane crescono e più persone entrano in contatto con polli anatre e maiali, aumenta enormemente la possibilità che si formino nuovi ceppi d’influenza” e che “l’influenza muta continuamente, come le figure che girano in una slot machine e di tanto in tanto – in cicli di circa ottant’anni – trova la combinazione vincente per produrre nuovi ceppi violentemente distruttivi per la vita umana”. Quammen, autore di un testo sulla dinamica dell’epidemie considerato un classico, racconta nel suo libro di aver riscontrato nella comunità dei virologi una risposta unanime alla questione da lui posta su quale origine avrebbe avuto una futura epidemia letale. “Nessuno degli esperti”, scrive, “contesta il fatto che il prossimo Big One, se accadrà, sarà una zoonosi [malattia infettiva che può essere trasmessa dagli animali all’uomo, n.d.a.]”. Intervistato qualche settimana fa da Wired, Quammen ha insistito sulla pericolosità insita nelle modificazioni dell’equilibrio ambientale: “Più distruggiamo gli ecosistemi, più smuoviamo i virus dai loro ospiti naturali e ci offriamo come un ospite alternativo. […] tutto è attirato verso di noi. Compresi i virus”.
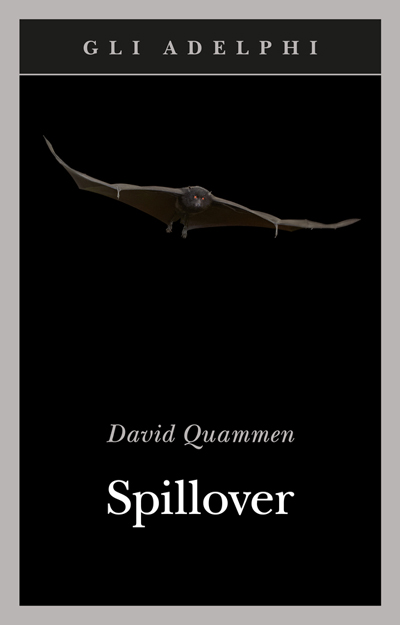
Sul finire degli anni Trenta, in tutt’altro contesto, Walter Benjamin denunciava i limiti insiti nel progresso. Il breve brano, che costituisce uno dei capitoli del libro Strada a senso unico, aveva per titolo Feuermelder. Letteralmente, segnalatore d’incendio.
Custoza, 2 aprile 2020
Bibliografia. Donald S. Burke, “Evolvability of Emerging Viruses” in Pathology of Emerging Infections, vol. 2, a cura di Ann Marie Nelson e C. Robert Horsburgh jr., American Society for Microbiology, Washington, 1998; “Bill Gates, The Next Epidemic. Lessons from Ebola in “The New England Journal of Medicine”, 372, 2015; James Howard Kunstler, Collasso. Sopravvivere alle attuali guerre e catastrofi in attesa di un inevitabile ritorno al passato, Nuovi mondi media, 2005; David Quammen, Spillover. L’evoluzione delle pandemie, Adelphi, Milano, 2014; Walter Benjamin, Strada a senso unico, a cura di Giulio Schiavoni, Einaudi, Torino, 2006.
SELVATICO
di Roberto Solieri, Graphic Designer
Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura,
ché la diritta via era smarrita.
Ahi quanto a dir qual era è cosa dura
esta selva selvaggia e aspra e forte
che nel pensier rinova la paura!
(Dante Alighieri – Inferno – Canto I – Dante e la selva oscura)

Dante Alighieri – La Divina Commedia Canto I.
Il mondo selvatico si risveglia assieme al fiorire di questa primavera e si ritrova in una condizione insolita dai diversi decenni precedenti. Non incontra più gli ostacoli umani che lo avevano fino ad oggi circoscritto, contenuto e menomato, si riappropria e ripopola gli spazi che fino a poco prima erano occupati e addomesticati dall’uomo. L’uomo stesso avverte un senso di smarrimento, costretto in uno spazio limitato inizia a pensare in modo diverso e si predispone a calarsi anch’essi nella condizione “selvatica”. In un primo momento acuisce i sensi e affina le strategie per mantenere integro il proprio status sociale prima di cedere inesorabilmente a un approccio più istintivo, una reazione creativa e spontanea al senso di privazione dei delicati equilibri legati alla propria routine quotidiana. Fioriscono le barbe incolte e un aspetto che si addice maggiormente al tempo libero che al lavoro, fa il suo ingresso a tempo pieno nella settimana l’abbigliamento comodo, conseguenza diretta dello “Smart Working”. Si considerano diversamente le risorse di spazio disponibili e nelle abitazioni si innescano situazioni conflittuali per l’accaparrarsi dei luoghi migliori dove svolgere i propri interessi, una sorta di ricerca di un luogo sicuro, della propria tana, preclusa agli altri membri della casa, dove rifugiarsi per ricaricare le batterie e declamare il proprio diritto alla privacy.
Il linguaggio si fa via a via più essenziale, la parola è ad appannaggio dei dispositivi tecnologici dai quali viene filtrata e incanalata in un abbecedario comportamentale. Si parla uno alla volta! Si alza la mano per parlare. Si cerca di esprimere in modo più sintetico ciò che si ha da dire. Come in un branco dove il “Maschio Alfa” che mette tutti d’accordo è rappresentato dal dispositivo tecnologico di turno. Senza il filtro disciplinante della tecnologia assistiamo inconsapevoli ad un impoverimento verbale, la quarantena finisce per dare eccessivo spazio alla retorica più viscerale, la confidenza tra le persone aumenta lasciando spazio ad espressioni di carattere più volgare, esternate spesso con la stessa naturalezza con la quale si chiede gentilmente il sale in tavola. L’uomo domestico, o per meglio dire “addomesticato” dall’educazione ricevuta e dalle circostanze socio culturali che ha assimilato lungo l’arco della sua esistenza, in queste condizioni particolari di reclusione forzata, regredisce naturalmente ad una forma più essenziale e per certi versi primordiale. Si trova inconsapevolmente ad agire in modo più diretto, dove gli schemi comportamentali seguono i bisogni primari lasciando libero sfogo a sentimenti di euforia, angoscia, rabbia e paura.
Custoza, 28 marzo 2020
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
di Costantino Di Sante, storico
In questo periodo di Coronavirus in molti si sono chiesti se il nostro SSN avrebbe retto. Il timore era dovuto da come il sistema era stato reso fragile dopo anni di de-finanziamento con la perdita di migliaia di posti letto, da un eccesso di “privatizzazione” e dalla mancanza di una vera cultura di pubblica managerialità. Inoltre, la preoccupazione maggiore era dovuta alla frantumazione in 21 sistemi regionali, con la sanità del meridione in profonda crisi. In tanti hanno ricordato come questa situazione da diverso tempo aveva tradito quegli obiettivi previsti nella nostra Carta Costituzionale: garantire a tutti i cittadini un uguale diritto alla salute e un accesso alle cure in tutto il Paese.
La Costituzione repubblicana all’art. 32 recita: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Insieme all’art. 38 la nostra Costituzione è una delle prime a riconoscere la tutela della salute di ogni cittadino. Per raggiungere questo obiettivo ci sono voluti diversi anni.
La tutela universale della salute è stata un passo enorme per il nostro Paese il cui sistema sanitario si basava su ben altre tradizioni. Ricordiamo che dopo l’Unità d’Italia era il Ministero dell’Interno ad occuparsi di salute e che questo approccio di “polizia” verrà cambiato in “Sanità Pubblica” solo nel 1888. Bisognerà attendere il 1907 per avere il “Testo unico delle leggi sanitarie” che poi il fascismo, nel 1934, aggiornerà per accentrare l’eredità del mutualismo operaio creando macro enti corporativi-assicurativi, promuovendo un sistema che accentuò le diseguaglianze prevedendo prestazioni sanitarie commisurate ai contributi versati dai lavoratori. Solo grazie alla lungimiranza e capacità dei nostri costituenti nel 1948 la salute diventerà un diritto fondamentale.
Questo principio, per circa vent’anni, rimase per lo più solo sulla carta. Piccoli passi furono fatti con la nascita del Ministero della Sanità nel 1958, che ingloberà l’Alto Commissariato per l’igiene e la sanità pubblica. Bisognerà attendere la seconda metà degli anni 60 per sentir parlare di SSN. In quel periodo viene reso operativo il “piano ospedaliero di primo intervento”. Il Ministero della Sanità con quello dei Lavori Pubblici pianificherà la realizzazione in quindici anni di almeno 82.000 posti letto, la maggior parte da destinare al Mezzogiorno. Il nuovo piano di salute pubblica raggiunse diversi risultati soprattutto sulla prevenzione: vaccinazione obbligatoria (cui simbolo è la sconfitta della poliomelite su tutto il territorio nazionale, grazie al vaccino Sabin); medicina scolastica; tutela delle attività sportive; riconoscimento giuridico della chirurgia dei trapianti d’organo con l’autorizzazione dei prelievi di parti di cadavere e promessa di una “legge antismog”, che purtroppo tarderà ad essere varata.
Malgrado questi passi avanti, la piena e totale istituzione del SSN arriverà solo grazie alla Legge 833/78, che entrerà in vigore il 29 gennaio 1979. La madre di questa legge sarà la prima ministra donna della Repubblica, l’on. Tina Anselmi. La stessa ministra che firmerà anche la cosiddetta Legge Basaglia sui manicomi e la Legge 194 sull’interruzione volontaria di gravidanza. Non è un caso che queste leggi, come quella della nuova sanità, prendono forma durante le lotte politiche e sociali degli anni settanta.

I principi che ispirarono la Legge 833 erano quelli previsti dell’art. 32 della Costituzione, essa prevedeva che: “il complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio”. La nuova legge ribalta la visione ottocentesca mettendo al centro non tanto la salute, ma il diritto alla tutela della salute. Prima del ’78 il sistema sanitario era basato sulle cosiddette Casse Mutue. Una forma di protezione assicurativa-previdenziale del lavoratore.
La riorganizzazione dell’assetto sanitario prevedeva una ripartizione delle competenze fra Stato e Regioni, con quest’ultime con il compito di programmazione ospedaliera, mentre il governo manteneva la centralità nelle politiche finalizzate alla tutela della salute e nel reperire le risorse economiche tramite il Fondo Sanitario Nazionale. Questo sistema, senza un’adeguata razionalizzazione e controllo delle spese, durante gli anni ’80, produsse corruzione e un forte deficit pubblico. Nel decennio successivo, si inizia a parlare di riordino del SSN e con i decreti del 1992-93 e del 1999 viene rafforzato il potere delle regioni che devono finanziare direttamente il proprio servizio sanitario, mentre le Unita Sanitarie locali (USL) sono trasformate in Aziende Sanitarie (ASL) datate di personalità giuridica e di una propria autonomia organizzativa che, tramite i Distretti sanitari, erogano le cure primarie.
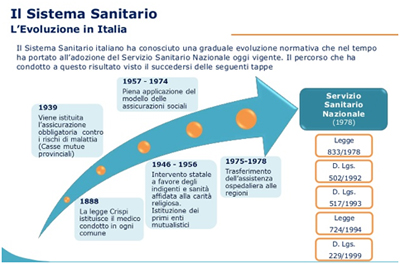
Il modo di gestire la sanità cambia radicalmente. Il nuovo indirizzo manageriale porta alla nascita di nuove figure del Direttore Generale e dei Direttori Amministrativo e Sanitario. Nel 2001 con la riforma del Titolo V della Costituzione, il SSN viene ridisegnato in un chiave “federalista”. Ogni regione deve assicurare i servizi sanitari e ospedalieri, mentre lo Stato mantiene la competenza sulla profilassi a livello internazionale. In sede di Conferenza Stato-Regioni viene messo in atto il Piano Sanitario Nazionale che prevede specifici obiettivi da raggiungere, i livelli essenziali di assistenza (LEA) che devono essere garantiti sul territorio nazionale e le risorse assegnate a ciascuna regione.

Questo è in grandi linee il sistema sanitario attuale che ha affrontato l’emergenza del virus Covid-19. Nonostante alcune inefficienze e criticità, a fatica e con grandi difficoltà, il SSN è riuscito a dare a tutti assistenza e cure gratuite. Sarà difficile tornare indietro ad un sistema completamente centralizzato, ma quest’esperienza ci ha ancora di più edotti su quanto sia importante e imprescindibile avere una Sanità pubblica. Per il futuro si spera che sia sempre meno imbrigliata nelle logiche amministrative-burocratiche e non più merce di scambio delle logiche politico clientelari.

Campli (TE), 29 aprile 2020
Bibliografia. Ferdinando Terranova, Lineamenti per la costruzione del Servizio Sanitario Nazionale, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1980; G. Paolo Zanetta e Cristiana Casalegno, Le leggi della nuova sanità, anno di edizione 1999; Vittorio Mapelli, Il sistema sanitario italiano, Il Mulino, Bologna 2012; Sitografia. www.slideshare.net/dbiselli/organizzazione-del-sistema-sanitario-italiano-dino-biselli-febbraio-2013.
SESSO
di Enrico Mottinelli, scrittore
Nel Tempo del Virus si sono rimarcati i confini: tra nazioni, regioni, province, comuni. Tra noi. Un metro. O forse, un vetro. Qualcuno è rimasto di là del muro di Berlino della paura e della precauzione. E penso agli amanti. Uno di qui, uno di là. Tra loro un vetro. Come quello che separava il bacio scambiato da Heidi Klum con il marito in una foto che ha girato sul web giorni fa.
Il Tempo del Virus ha imposto agli amanti separati di parlare una lingua diversa. Innaturale. Loro che comunicano con l’alfabeto dei corpi che si sfiorano, che si toccano, che si compenetrano, che si guardano senza veli, senza diaframmi. Ora a disposizione ci sono solo le parole. E uno schermo. I corpi tacciono, o, meglio, fremono impazienti nella loro contenzione. Cosa si diranno gli amanti separati per surrogare il mutismo forzato dei corpi? Come trasformare in parole o immagini la sensazione di un contatto che non può esserci? Come trasmettersi l’estasi?

Sarebbe bello, il giorno in cui questa tragedia sarà passata, raccogliere in un libro, che immagino impossibile da rilegare tante sarebbero le sue pagine, le espressioni, le allusioni, le metafore, gli stratagemmi che la fantasia dell’amore sta producendo in questi giorni per unire i corpi degli amanti separati; depositare sulla carta la tensione e il desiderio che circola nell’aria nel tentativo di scavalcare le barriere. L’amore sta componendo un suo nuovo, interminabile vocabolario che la tecnologia diffonde nell’etere. Non è dunque solo disagio o paura o disperazione quello che respiriamo intorno a noi, c’è anche il desiderio degli amanti, i loro corpi che si cercano pronunciando parole che non si erano udite mai.
Milano, 23 marzo 2020
SILENZIO
di Enrico Mottinelli, scrittore
Nel Tempo del Virus, tempo sospeso, da fiato trattenuto, si sono smorzati i rumori. Lo si coglie molto bene soprattutto nelle città. Milano, per esempio, ha perduto quasi d’un tratto quel rombo sordo che non si placava mai, giorno e notte. Cessando un suono o un rumore qualsiasi, lo si udiva subito. Un sottofondo, un respiro inquieto, con l’unico ossessivo messaggio che c’è sempre qualcosa da fare, e si è sempre in ritardo. Ora più nulla. Quasi fischiano le orecchie.

Servizio a corredo articolo sul Coronavirus per Russello e web – fotografo: ©Andrea Pattaro/Vision
Ora abitiamo in un panorama acustico differente. Le cause dei suoni adesso sono meno astratte, più immediate. I pochi passi concessi lungo le strade fanno il rumore dei pochi passi concessi; un portone che si chiude quello di un portone che si chiude; un saluto quello di un saluto. E tra uno e l’altro il silenzio. Nelle città del Tempo del Virus è comparso il silenzio. Milano, per esempio, ne è sbigottita. All’inizio la si è presa quasi sul ridere. Poi è scattata la voglia di rompere il silenzio tutti insieme, a mezzogiorno, alle sei del pomeriggio, dai balconi: applausi, canzoni, recite improvvisate.
Poi i morti, sempre di più, e le ambulanze che sostano anche sotto casa e portano via qualcuno. Ed è cominciata la paura. E il silenzio ha cambiato segno. Il silenzio infatti non è mai muto. È la cassa di risonanza dei rumori, dei suoni e delle voci che ci portiamo dentro. Così, il silenzio del Tempo del Virus ci apre un orecchio rivolto all’interno. E quello che si ode può avere tanti significati, frastuoni o melodie, vuoti o pienezze, cacofonie o racconti, dipende. È questo che portiamo poi sui nostri balconi. Con il suo silenzio, il Tempo del Virus ci mette di fronte a noi stessi e ci espone ai balconi, ed è forse la prova più dura.
Milano, 23 marzo 2020
SMARRIMENTO
di Anna Maria Molino, oncologa e docente a contratto univr
Sono un medico smarrito, incredulo, attonito di fronte a quello che sta succedendo. Ho cominciato a svolgere la mia professione nel 1975 e mi sono dedicata all’Oncologia, disciplina all’epoca praticamente inesistente, perché non c’era nessuna possibilità di curare i pazienti. In 45 anni ho assistito a una rivoluzione in Oncologia e in molti altri ambiti clinici. La mia generazione di medici ha vissuto un’epoca straordinaria e sorprendente: tutto sembrava possibile in Medicina. E in effetti tantissimo è stato possibile. Siamo arrivati a capire molto dei processi molecolari che causano le malattie e, di conseguenza, a trovare cure impensabili fino a pochi anni fa. La Medicina di oggi è molto potente, sono scomparse molte malattie infettive, dall’epatite C si guarisce, l’AIDS si cura, molti pazienti con tumore hanno un’aspettativa di vita normale, le malattie cardiovascolari sono ben controllate, si fanno progressi continui. L’aspettativa di vita è quasi raddoppiata in un secolo. E allora come è potuto avvenire questo disastro solo per un piccolo virus?
Continuo a leggere aggiornamenti perché mi pare impossibile che sia veramente successo, mi sembra di assistere a un brutto film catastrofico. Adesso veniamo a sapere che negli anni scorsi erano state studiate delle simulazioni su quel che sarebbe successo in caso di pandemia, ma credo che nessuno veramente pensasse che non saremmo riusciti, come mondo medico, a controllare un semplice virus. Certamente ci sono state delle sottovalutazioni, degli errori nelle procedure, e mi chiedo come mai ci siano stati, dato che in Medicina siamo abituati ad affrontare situazioni molto difficili e complesse, ma non voglio parlare degli errori, lo stanno già facendo in troppi, con opinioni spesso contrastanti. Voglio invece comunicare il mio smarrimento di medico nell’osservare una strage che non avrei mai immaginato di vedere. Ci sono stati anche molti decessi; più di cento medici e molti operatori sanitari sono tra i morti ed è incredibile che questo sia avvenuto nel 2020 in Paesi sviluppati. Nei miei 45 anni di professione non mi era mai successo di veder morire medici sul campo nei nostri Paesi. MAI. Posso solo constatare che la Medicina non è cosi potente come pensavamo e uscirà ridimensionata e cambiata da questa crisi.
Come, non lo so. Spero in meglio.
SMART WORKING
di Elisa Preciso, smart worker
Letteralmente significa “lavoro agile”. Ma cosa si intende con “agile”? Forse, significa che indossare una tuta, o, perché no, restare direttamente in pigiama, è sicuramente più “agile” del dovere indossare abiti adeguati ad un ambiente aziendale. O, forse, che non dovere prendere l’auto per spostarsi è sicuramente più “agile” del doverlo fare. O, forse, che è possibile gestire la propria attività lavorativa sulla base delle proprie esigenze, anche molto personali, senza dovere seguire i ritmi dettati dalla timbratura di un badge. Che meraviglia lavorare così! Peccato, però, che non sempre gli strumenti siano adeguati. Chiariamo. Non dividendo i medesimi spazi fisici, i vari collaboratori devono coordinare la propria attività tramite chat di ogni tipo: alcune costituite da innumerevoli messaggi di testo, cui, tutto sommato, si è abituati grazie all’indefessa attività messaggistica che la gran parte degli esseri umani ha sviluppato tramite WhatsApp.

Altre, e sono la grande rivoluzione in tempi di COVID-19, sono costituite dalle videochiamate su piattaforme di vario genere. Vedersi e sentirsi restando a casa. Forse sarebbe più corretto dire vedersi o sentirsi. Perché le due cose, vedersi e sentirsi appunto, non sempre vanno assieme. Problemi audio, problemi video, problemi di connessione alla propria wireless, o al proprio hotspot rendono il tutto, a volte, piuttosto difficoltoso. Ma per il business si supera anche questo e così, dopo due o tre tentativi, si riesce, finalmente, ad avviare una efficace videoconferenza. E la nostra condizione mentale? Lo “smart working” ci rende migliori. Le relazioni professionali con i colleghi sono più cordiali e meno incalzanti. Mancando totalmente la “visceralità” che, spesso, logora le relazioni in presenza, si è tutti più gentili e rispettosi. E più calmi. La frenesia lavorativa sembra gestibile. Non si ferma tutto, se non si è in ufficio. E noi recuperiamo anche la nostra umanità che, a volte, si perde nei corridoi della nostra azienda.
Verona, 1 aprile 2020
SOLITUDINE
di Michele Cavejari, tanatologo e giornalista
Dal latino solitudo, il termine allude tanto alla difficile stagione interiore in Zona Rossa quanto alla fisicità claustrale dei domicili e la desolazione delle piazze. La sua verità, tuttavia, valica i perimetri dell’ordinanza formale – ossia trascende il volto dell’isolamento – eccedendo ovviamente l’assenza di contatti, nel senso che il “vuoto” ha potuto raggiungere persino le abitazioni più “piene” (di beni e presenze).
Dunque, nonostante a primo acchito la folta chioma della “solitudine ai tempi del COVID” testimoni l’atomizzazione della vita sociale e generazionale (quest’ultima, alla voce: i giovani rispettino la distanza dai vecchi), il tronco del medesimo albero si erge forse nell’oblio di sé che da lunghi anni precede la pandemia; un albero le cui radici sono troppo spesso nutrite da consumi e prestazioni ossessive: là dove già una maschera la si indossa (per apparire come “qualcuno”) e il vero viso, l’essere, giace non indagato; e ancora, là dove la performance – ricorda il filosofo contemporaneo Han – soffoca il tempo dello spirito meditativo e l’otium caro ai latini…
Fondamentalmente, ci siamo ritrovati sguarniti “dentro” quando l’ospite inquietante (parafrasando Nietzsche) si è presentato “fuori”. Con ogni evidenza, se De André per primo affermava che vecchi e malati non si possono permettere la solitudine, lo si deve al fatto che la solitudine non si limita a “visitarci” per intermittenze ma “fonda” la condizione tipicamente umana dello stare al mondo. L’uomo, del resto, è sicuramente una specie sociale ma si ritrova “ontologicamente solo” in quella che Heidegger definisce gettatezza nell’esser-ci (Da-sein), ossia in un mondo e in un corpo che non ha scelto… ontologicamente solo, cioè, a cospetto della richiesta di senso, ai bivi e alle tappe decisive del cammino esistenziale; su tutti, alla nascita e alla morte.
In via generale, la solitudine può essere allora immaginata come l’oceano su cui prende forma l’arcipelago delle relazioni; anziché l’oasi, l’anomalia, in una terra vasta e ricca di contatti. Ma può essere letta anche come il punto panoramico da cui zampilla, per l’artista e il filosofo, lo sguardo colmo di meraviglia, la fonte della creatività. In chiave ossimorica, solitudine è relazionalità in quanto fonda il riconoscimento dell’Altro. E unicamente chi ha imparato a stare con sé stesso può apprezzare l’alterità in pienezza, coltivando la relazione senza precipitare nella con-fusione. In solitudine, l’uomo scopre il mondo che ha dinnanzi e il mondo che ha in sé, le predisposizioni interiori, i doni da portare nel mondo: la ghianda da rendere quercia, direbbe James Hillman.

In solitudine, l’uomo scopre di non essere solo…
L’immaginario moderno scosso dal virus, in buona sostanza, ha dovuto riconoscere forzatamente la solitudine che tutti ci abita. La stessa solitudine che però, scelta o imposta, non è mai un male in sé. Certo, è faticosa, e per molti di noi lo è stata durante le settimane di lockdown; ma, chiediamoci: ciò non lo si deve – almeno in parte – al fatto che già prima di viverla in prima persona evidentemente stavamo agendo come estranei, stranieri a noi stessi? La solitudine, dopotutto, non è che lo specchio fedele dei paesaggi interiori.
Stare “con” la solitudine richiede coraggio dacché chiama a sostare in compagnia di tutti gli irrisolti relegati nelle carceri interiori; ed essenzialmente insegna a fare di quelle carceri i luoghi di riabilitazione e cura, per riconoscere nel demone della caducità e della finitudine il seme della bellezza.
Forse non si esagera nel dire che la solitudine ai tempi del COVID-19 è l’emblematico monito rivolto a chi abitava il mondo senza conoscersi o senza vestire un pensiero critico; lo spauracchio “necessario” per chi fuggiva i disagi interni con l’iperattività e il branco. Questa solitudine, del resto, ha sottratto il consumatore al conformismo rassicurante del gregge, chiedendogli di divenire responsabile verso il prossimo e di vestire così i panni da cittadino.
Il solitario, ricordiamolo, non è l’antisociale; intraprende un passaggio necessario per l’emancipazione interiore, così come ci insegna Jung parlando del processo d’individuazione: dacché preservare la solitudine equivale a concedersi un faccia a faccia con l’ombra, i lati oscuri, le paure… per trovare la libertà di essere sé stessi. Il virus, insomma, ha dettato l’isolamento, ma quest’ultimo, ai più ricettivi, ha mostrato la via lungo la quale le battaglie esteriori possono essere finalmente riconosciute come proiezioni dei conflitti interiori.
Per chiudere, un buon cristiano, ai tempi del COVID, aggiungerebbe che stare in solitudine è altresì concedersi un faccia a faccia con Dio, poiché solo nel mistero della solitudine silenziosa (ci ricorda Enzo Bianchi) v’è il mistero del Verbo. Così come Cristo dovette affrontare il deserto e il silenzio del Padre per conoscerne l’amore, al pari i figli di Dio hanno dovuto dimorare nel silenzio del Sabato (ore di morte e malattia) nonché nella solitudine della Croce (simbologia peraltro rievocata in vista della Pasqua 2020 dallo stesso Bergoglio) al fine di comprendere la resurrezione e la comunione, che è far comunità Vera.
Non dimentichiamo che la stessa Adriana Zarri ci richiamò alla radice materna della solitudine per crescere bene l’albero della comunità. La scrittrice e teologa, emblematicamente, si rifece al titolo di uno dei suoi libri più belli (e più fecondi, da affrontare specie in quarantena) onde ricordare che un eremo non è un guscio di lumaca.
Fuor di metafora, star soli non è tagliarsi fuori, ma l’occasione propizia per iniziare a coltivare l’interiorità, vivificando la fratellanza a partire da un esercizio di coscienza e cuore, di interiorizzazione valoriale. Soltanto l’uomo capace di reggersi sulle proprie gambe, ovvero di camminare da solo, in solitudine – chiariva Zarri –, è in grado di erigere una comunità matura, popolata da adulti, anziché da immaturi predati da fragilità nervose, ideologiche e morali… costretti cioè a puntellarsi l’un con l’altro anziché liberi di reggere l’altro. Una lezione rara, quella che la solitudine “da Covid” ha rivolto alla società del turboconsumo (come la definisce l’economista e filosofo Serge Latouche): fendere la mentalità di massa, esplorarsi e rifiorire (ci si augura) come comunità.
Verona, 20 aprile 2020
Bibliografia. E. Bianchi, Le parole della spiritualità; B.-C. Han, La società della stanchezza; M. Heidegger, Essere e Tempo; J. Hillman, Il codice dell’anima; C. G. Jung, Coscienza, inconscio e individuazione; S. Latouche, Per un’abbondanza frugale; A. Zarri, Un eremo non è un guscio di lumaca.
SONNAMBULISMO
di Carlo Saletti, storico e regista teatrale
Quando ne sapremo di più, quando cioè saremo nella posizione sicura di chi si è lasciato il cataclisma alle spalle, potremo convenire sul fatto che la pandemia causata dall’agente patogeno chiamato SARS-CoV-2 appartiene a quella famiglia di eventi radicali che si pensavano improbabili, perlomeno finché non si sono verificati. E una volta verificatisi, si pensavano domabili, sino ad accorgersi che erano davanti a noi e lo restavano, perché più veloci a progredire. C’è una certa aria di famiglia fra i processi, umani o naturali, che cambiano la storia e che li fa assomigliare uno all’altro.
Per spiegare cosa favorisca la mancata comprensione di ciò che, pur stando sotto gli occhi, si rivelerà catastrofico nel brevissimo periodo, la scienza storica ha fatto ricorso alle sfuggevoli nozione di sonnambulismo – attività motoria a carattere automatico propria di chi ambula nel sonno – e di sonnambulo – colui che, secondo lo scrittore viennese Hermann Broch, “avanza a tentoni, tenendosi al filo di una qualche logica di corto respiro, attraverso un paese chimerico, che chiama realtà, sebbene non sia per lui che un incubo”.
Le élites politiche e tecnocratiche europee si sarebbero comportate da sonnambule nelle prime settimane dell’estate 1914, e come affetta da sonnambulismo si sarebbe mossa l’opinione pubblica francese nel 1940 con l’estate alle porte, mentre le armate tedesche marciavano su Parigi. Il giornalista spagnolo Manuel Chaves Nogales, esule in Francia dal 1937, assistette incredulo all’inerzia che accompagnò l’arrivo del cataclisma nella capitale: “Un ristorante alla buona, un letto, un tavolino all’aperto libero, dove prendere comodamente l’aperitivo, un biglietto per il cinema […] erano più importanti per quella massa variopinta di tutte le angosciose preoccupazioni nazionali del momento. Quante di quelle persone erano coscienti di vivere un’ora decisiva per loro e per la storia”?

Ora, è capitato lo stesso nel febbraio di quest’anno. Non abbiamo forse pensato, tutti noi, improbabile che ciò che era già presente nel paese – è del 31 gennaio 2020 la delibera del Consiglio dei ministri dove si dichiarava “lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” – potesse dare origine all’epidemia che avrebbe cambiato le nostre vite? Come ha immaginato l’impatto del virus il nostro governo? Il 30 gennaio, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte annunciava in una conferenza stampa che: “Eravamo già molto vigili e molto attenti nel monitorare l’evoluzione di questa situazione critica, non ci siamo fatti trovare impreparati. Abbiamo chiuso il traffico aereo da e per la Cina. A quanto ci risulta, siamo il primo paese dell’Unione Europea che adotta una misura cautelativa di questo genere” (nel video dai minuti 2.17 a 2.54). Rispondendo alla domanda di un giornalista, concludeva dichiarando che: «Vi posso assicurare che in questo momento in Italia abbiamo adottato una linea di massimo rigore in funzione preventiva. Da questo punto di vista siamo assolutamente nella condizione di poter tranquillizzare tutti i cittadini […]. La situazione è assolutamente sotto controllo” (dai minuti 16.07 a 6.40). Incomprensibile appare la richiesta – avanzata dalla Regione Veneto il 9 marzo, all’indomani del primo decreto con cui il governo dichiarava la messa in quarantena della Lombardia e di 11 province tra cui quelle di Venezia, Padova e Treviso – di stralciare le province venete dal decreto, non comprendendosi la ragione “di una misura che appare scientificamente sproporzionata all’andamento epidemiologico”.

Il sonnambulismo con cui le le leadership europee hanno assistito all’avanzare dell’epidemia è sorprendente. Mancando una direzione comune di coordinamento delle politiche europee di contenimento dell’epidemia e pur di fronte del drammatico aumento di casi di contagio e di decessi che si registravano in Italia, la condotta di ciascun paese è stata ispirata a un irresponsabile attendismo. Solo lunedì 16 marzo, nel messaggio televisivo rivolto al paese, il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron ha riconosciuto l’esistenza di una “guerra sanitaria” che richiede i provvedimenti più drastici per essere combattuta. Se pure inconsapevolmente, nella solenne allocuzione rivolta ai concittadini Macron si è trovato a ripetere le considerazioni che Nogales aveva lasciato scritte ottant’anni prima: “Abbiamo visto persone riunirsi nei parchi, nei bar […] come se la vita non fosse cambiata”.
Custoza, 1 aprile 2020
Bibliografia. Christopher Clark, I sonnambuli. Come l’Europa arrivò alla grande guerra, Laterza, Bari, 2013; Hermann Broch, I sonnambuli, Mimesis, Milano, 2010; Manuel Chaves Nogales, Agonia della Francia, Neri Pozza, Vicenza, 2014.
SPAGNOLA
di Costantino Di Sante, storico
“Non c’è la statistica dei morti di spagnuola, perché la ‘maledetta’ continua ad ammazzare!”. Queste le parole riportate sul periodico socialista La Squilla di Bologna nel gennaio del 1919. Ancora oggi dare dei numeri certi su quanti siano stati i morti per l’epidemia della spagnola, che interessò l’intero pianeta dal 1918 al 1921, non è semplice. Gli studi più recenti parlano di 100milioni di morti, altri attestano cifre tra i 25 e i 50 milioni (ricordiamo che la Grande guerra fece 17 milioni di morti). Si tratta sempre di stime difficili da poter confermare con certezza visti gli strumenti di allora. Comunque rimane la pandemia più grave della storia dell’umanità, capace di contagiare almeno 500milioni di persone su una popolazione totale di circa 2 miliardi.
La sua micidiale letalità, a differenza dell’attuale Coronavirus, colpiva giovani apparentemente sani e non bambini, anziani o persone indebolite da altre malattie. Si ritiene che l’elevata mortalità, che colpì soprattutto gli uomini tra i 20 e i 40 anni e le donne incinte, fosse dovuta alle energiche reazioni immunitarie (una “tempesta di citochine”) che gli adulti in buone condizioni fisiche erano in grado di produrre. Queste determinavano delle severe insufficienze respiratorie con conseguenti edema polmonare e forti emorragie. Per alcuni studiosi i motivi della sua particolare aggressività sui corpi sani, erano dovuti anche alle condizioni che si vennero a creare durante la guerra: malnutrizione, mancanza di igiene, campi medici e ospedali sovraffollati. Inoltre, gli spostamenti di truppe, di sfollati e di profughi contribuirono a diffondere la letale infezione batterica.

dei malati di spagnola
Solo alcuni anni fa è stato scoperto il virus responsabile della spagnola. La paleopatologa Kirsty Duncan nel 1997 riuscì a recuperare nel Circolo Polare Artico i cadaveri di sette giovani minatori morti di spagnola nel 1918. Rimasti sepolti nei ghiacci perenni, avevano conservato tracce del virus sottotipo H1N1 dell’influenza così la dottoressa li potè analizzare nel suo laboratorio, risultando essere un ceppo simile a quello dell’influenza suina del 2009, ma diverso dal Covid-19 che fa parte del gruppo della Sars.
Nonostante siano passati più di cento anni, ancora non sappiamo dove la spagnola ebbe origine. Tra le ipotesi più accreditate c’è quella che il paziente zero sia stato individuato in una base di addestramento militare del Kansas. Successivamente le truppe americane avrebbero diffuso il virus in Europa.

Secondo altri studi ebbe origine in un campo militare nel Nord della Francia (a Étaples) non lontano da Calais. Prima della battaglia della Somme del 1° luglio 1916, in questa zona particolarmente umida e paludosa, stazionavano le truppe britanniche in condizioni di promiscuità, a contatto con animali di vario tipo e con il terreno la cui salubrità era stata compromessa dall’uso delle armi chimiche. Un’altra tesi, meno accreditata, sostiene che sia arrivata dalla Cina dopo la sua entrata in guerra nel 1918 con almeno 100mila soldati cinesi inviati in Francia. Di certo, nonostante il nome, non ebbe origine in Spagna. I Paesi che stavano combattendo non vollero dare l’annuncio dell’epidemia perché ciò avrebbe demoralizzato le truppe. Invece, della micidiale influenza, sulla stampa della neutrale Spagna già se ne parlava ampiamente fin dai primi mesi del 1918. A renderla ancora più conosciuta come spagnola, concorse anche il fatto che contagiò il re Alfonso XIII.
La pandemia colpì la popolazione mondiale almeno con tre principali ondate: una nella primavera del 1918, l’altra, la più letale, nell’autunno dello stesso anno e l’ultima nell’inverno successivo che, con la smobilitazione degli eserciti, si prolungò fino al 1920. Secondo alcuni vi fu una quarta ondata nel 1921 che interessò soprattutto le isole del Pacifico.

Anche quando gli ultimi focolai si spensero, seppure in Europa contribuì a far nascere il sistema sanitario statale, la spagnola lasciò dei dolorosi segni in varie parti del pianeta. Negli anni venti, come diretta conseguenza, si diffuse in tutto il mondo l’encefalite letargica, la “malattia del sonno”.

Nonostante questi dati è sconvolgente come la pandemia di spagnola sia stata dimenticata. Un recente studio di Roberto Bianchi ci dice che sui manuali di storia e anche su alcuni testi molto diffusi che si occupano del ’900, della “maledetta” quasi non c’è traccia. Probabilmente, nei primi anni, a farla dimenticare in fretta, vi fu il trauma che aveva provocato e la volontà di guardare avanti mettendo al centro la più “rassicurante” narrazione della guerra con eroi e nemici più facili da individuare.
Anche allora, come oggi, per limitare il contagio ci fu bisogno dell’isolamento dei malati, del mantenimento della distanza con il portatore del contagio, delle quarantene e dei cordoni sanitari. Si spera che in futuro, ciò che all’epoca fu scordato troppo in fretta, non venga dimenticato perchè il genere umano “vive in un equilibrio instabile con il resto della natura che lo circonda”.

dall’influenza su un giornale canadese
Campli, 6 maggio 2020.
Bibliografia: Roberto Bianchi, La “spagnola”. Appunti sulla pandemia del Novecento, in Passato e presente, 31 marzo 2020, (https://amicidipassatoepresente.wordpress.com/2020/03/31/la-spagnola-appunti-sulla-pandemia-del-novecento-roberto-bianchi/; Laura Spinney, 1918. L’influenza spagnola. La pandemia che cambiò il mondo, Marsilio, Venezia, 2018; Eugenia Tognotti, La “spagnola” in Italia. Storia dell’influenza che fece temere la fine del mondo (1918-1919), FrancoAngeli, Milano 2002; Gina Kolata, Epidemia. Storia della grande influenza del 1918 e della ricerca di un virus influenzale, Mondadori, Milano 2000; Paolo Giovannini, L’influenza “Spagnola” in Italia (1918-1919), in La grande guerra e il fronte interno. Studi in onore di George Mosse, a cura di Francesca Magni, Alessandra Staderini, Luciano Zani, Università degli Studi di Camerino, Camerino 1998, pp. 123-141; Richard Collier, La malattia che atterrì il mondo, Mursia, Milano 1980.
SPAGNOLA, MEMORIA
di Miriam Perbellini Carmi, avvocato
”Spagnola” fu la pandemia influenzale che tra il 1918 ed il 1920 uccise milioni di persone nel mondo. Prese questo nome perché a darne per primi la notizia furono i giornali della Spagna – neutrale nel conflitto mondiale in corso – liberi pertanto dalla censura militare vigente negli altri paesi
Era nata nel 1895, terza di quattro fratelli. Non amava raccontare di sé – troppi lutti nella sua lunga vita – ma talvolta, quando restavamo sole io e lei, allora qualche episodio della sua infanzia o della sua giovinezza emergeva dalla sua memoria. Ricordo per esempio come amava parlare di quella foto, datata 1900: allora, andare a scattare una foto, era quasi un “evento”, in vista del quale ci si preparava per giorni, decidendo quale vestito indossare e come acconciarsi i capelli, consapevoli dell’importanza e della specialità che quel fatto rivestiva.
Rideva, la nostra vegliarda, nel modo in cui ridono coloro che come lei hanno quasi sfiorato i cent’anni, ripensandosi e rivedendosi bambina. Eccola, nella foto, in piedi nel suo vestito di bimba di 5 anni, da cui spuntavano, seppure pudicamente, due quasi mutandoni adornati da un pizzetto ricamato, accanto alla mamma ed al nonno, seduti invece l’uno accanto all’altra. Augusto, il fratellino di soli 3 anni, una massa di riccioli biondi come la sorellina, stava pure in piedi dall’altro lato, vicino al nonno, che si teneva il cappello sulle ginocchia. Infine, i due fratelli maggiori, Attilio ed Italia, collocati in piedi dietro mamma e nonno, così da creare una composizione armoniosa.

Nessuno di loro sorrideva, tutti guardavano seriosamente il fotografo; forse solo i due più piccoli, nei grandi occhi curiosi e sopresi, sorridevano un po’. Per l’occasione, per rendere ancora più speciale la gita che avrebbe portato tutta la famiglia dal piccolo paesino in collina dove abitava ad un centro più grande, degno di avere la bottega di un fotografo, la mamma della nostra protagonista aveva lavorato a maglia due fiocchi di lana rossa, che il fatidico giorno furono apposti sulle orecchie del cavallo che guidava il biroccio. Amava descrivere il movimento buffo e festoso di quei fiocchi colorati sulle orecchie dell’ignaro cavallo, e mentre parlava nei suoi occhi si accendeva quella luce ridente della bambina che era stata e che tanto si era divertita quel giorno.

La “spagnola” (nota 1), arrivata nel 1918, si era portata via prima la mamma e poi i fratelli maggiori, Italia ed Attilio. Anche lei si era ammalata, con febbre altissima, che quasi la portò al delirio. Poi la febbre scese e lei si salvò. Ricordava un sogno, fatto durante il delirio: era in un prato e al di là di un ruscello vide tanti bambini giocare felici; tra di essi anche una sua cuginetta, che era pure mancata da poco a causa della spagnola. Allora lei chiamò la sua compagna di giochi e le chiese se poteva attraversare il ruscello per unirsi a loro nei giochi. La bimba si allontanò, andando a porre la domanda a Gesù, che era in mezzo ai bambini festosi. Fatta la propria ambasciata, la cuginetta tornò e riferì: “No. Gesù ha detto che per te è troppo presto”. Dopo aver sentito queste parole, la nostra improvvisata testimone di quel tempo mi raccontò che si era svegliata, che la febbre era calata e si era sentita meglio. Il racconto di questo sogno terminava sempre con le parole: “E da allora sono ancora qui”, pronunciate con un sorriso innocente ed ancora meravigliato.
Questa bambina si chiamava Emilia Alba ed era la mia nonna.
Verona, 29 aprile 2020
SPESA
di Claudia Caliari, casalinga
Il momento per fare la spesa è da sempre una necessità che ogni famiglia non può non soddisfare. E’ una questione di sopravvivenza. Mangiamo tutti i giorni almeno due volte al giorno e tutti abbiamo bisogno di prodotti per la nostra pulizia e quella della casa. Per una buona fetta di popolazione la spesa è un momento da espletare velocemente la sera dopo il lavoro, prima di rientrare a casa; oppure il sabato, affrontando con coraggio il caos e l’affollamento dei grandi supermercati. Per altri, invece, è un momento di autentica socialità durante il quale incontrare qualcuno nelle corsie dei negozi diventa un importante momento della giornata in cui spesso la solitudine di chi vive da solo concede qualche instante di tregua: una chiacchierata più o meno lunga per scambiare commenti su come vanno le cose in generale o sul tempo che farà nei prossimi giorni. Per questa tipologia di persone non esiste la fretta se non quella dettata dal mezzogiorno che arriva e che richiede l’attenzione di chi deve preparare il pranzo.

Tutto questo prima del DPCM del 9 marzo 2020, giorno in cui tutto è cambiato.
Improvvisamente il termine “spesa” assume un significato rilevante e a tutti gli effetti definito di “assoluta necessità”. Diventa un momento che ha bisogno di una dichiarazione da sottoscrivere e da esibire ad un eventuale controllo da parte di una qualche autorità. Diventa un lascia-passare per varcare il confine che delimita il territorio in cui possiamo muoverci. Diventa un motivo dominante che giustifica la nostra uscita, il motivo per il quale possiamo, senza vergognarci, dichiarare che era assolutamente necessario uscire. L’ora prescelta per la spesa non è più dettata dalla fretta del “dopo-lavoro” e non è più una scusa per incontrare qualcuno. Si cerca di fare la spesa nelle ore meno affollate e il più velocemente possibile. Ci si prepara accuratamente: la lista è lunga e deve soddisfare le esigenze familiari per più giorni, meglio se per l’intera settimana; per i più bravi ed esperti, la lista segue l’ordine della merce esposta, un vantaggio per fare presto; s’indossa la mascherina che proteggerà dai possibili e pericolosi effetti che un saluto può provocare; è stato reso obbligatorio indossare un paio di guanti “usa e getta” che faranno da barriera tra le nostre mani e le eventuali superfici contaminate.

L’approvvigionamento dei viveri non è più un fatto banale e scontato, può essere una questione di vita o di morte: un’uscita furtiva e frettolosa durante la quale il virus, “ cecchino invisibile”, può sparare a tradimento e in ogni momento. Nei supermercati non sono più ammessi affollamenti, occorre rispettare la distanza stabilita nelle code in entrata e alle casse. In alcuni si entra solo dopo aver misurato la febbre A nessuno di noi viene voglia di conversare del più e del meno, ognuno torna a casa con i propri pensieri e la propria solitudine.
Sommacampagna (Vr), 5 aprile 2020
SPIRITUALITA’
di Monica Cornali, psicologa e tanatologa
“Questa vita, dentro cui siamo capitati nascendo senza sapere perché, ha mille ragioni per essere una grazia , e mille altre per essere una disgrazia: ma cosa è vero? Che è una grazia, o una disgrazia? E poi i nostri morti….è un bene o un male che essi siano esistiti, che siano apparsi in questo mondo? Se alla fine comunque si deve morire, è meglio nascere o non nascere, essere stati o non essere mai stati? Che cosa è vero, alla fine?” Così si esprime il teologo Vito Mancuso. Ciascuno di noi, nel momento in cui si pone queste domande attinge alla sua dimensione spirituale. La spiritualità, infatti, risponde ad una tensione intima alla trascendenza che caratterizza tutti gli individui, che è originaria rispetto a qualsiasi rappresentazione e regola culturale e che si distingue dalla “religiosità” (Testoni, 2015), pur potendo anche incanalarsi in una forma religiosa.
L’uomo si ritrova da sempre circondato, assediato, dal mistero della vita, che lo affascina ed insieme lo angoscia. Vi è in lui il tentativo di venire a capo del mistero della vita nella sua globalità, di afferrare la sua bellezza e di non venire schiacciato dalla sua imponderabilità. Egli si pone domande di senso, ricerca il bene, si scopre essere limitato eppure anelante l’infinito.
Viktor Frankl, psichiatra che ha vissuto l’esperienza del lager – da cui poi è scaturita la messa a punto del suo approccio psicoterapico, la logoterapia, basata sulla ricerca di significato – ha parlato di “Dio nell’inconscio”, proprio riferendosi alla dimensione preverbale della spiritualità umana.
La tensione intima alla trascendenza può costituire, se ben orientata, una fonte di resilienza, di forza e di energia sia di fronte alle sconfitte ed alle sofferenze che inevitabilmente si incontrano nella vita (Pangrazzi, 2011), sia per affrontare il tema della morte e l’esperienza del morire (Testoni, 2015). Coloro che si occupano di cure palliative sanno quanto sia importante, oltre all’aspetto fisico e psicologico, la cura della dimensione spirituale del malato e dei familiari, affinché, in base ai percorsi di vita, alla mappe interiori ed all’orizzonte di valori, possa attingere ad un senso di pacificazione, fiducia e compimento della sua parabola terrena, agevolando in tal modo anche il processo di elaborazione del lutto.
A pochi che muoiono quando la misura della loro vita è colma, si contrappone la grande schiera di quelli la cui vita ci pare incompiuta, per i quali non è nemmeno il caso di parlare di adempimento nel senso dell’individuazione. Da qui al sentimento della tragicità o addirittura dell’insensatezza non c’è che un passo; e tuttavia non disponiamo d’altro che di riflessioni umane e soggettive che prendono a presupposto la norma di una vita realizzata, vissuta in maniera ottimale, di lunghezza media. Quale sia stato oggettivamente, sub specie aeternitatis, il destino di una vita e quale ne fosse il senso, l’uomo non lo può accertare: “La risposta alla vita umana non si trova entro i confini di questa vita” (C.G.Jung, Lettera alla signora Oppenheim, 12 agosto
1933, in Incontri con la morte).

Allo stato attuale, la prospettiva giudaico-cristiana, così come è stata fino ad oggi interpretata (Testoni, 2015) si mostra inadeguata a fornire orizzonti di senso all’uomo contemporaneo. Anche il paradigma scientifico è assai carente; vengono alla mente alcune parole di Wittgenstein: “Noi sentiamo che, persino nell’ipotesi che tutte le possibili domande scientifiche abbiano avuto risposta, i nostri problemi vitali non sono ancora neppure sfiorati”. Siamo rimasti sguarniti di un linguaggio adeguato per poter esprimere l’inesprimibile: quella speranza, quella certezza di essere eterni (Testoni, 2015) che da sempre ci abita. Tale linguaggio, diverso da quelli che fino ad oggi le religioni hanno adottato sotto l’egida di terrore/peccato/redenzione, è tutto da
inventare e cominciare a farlo con le nuove generazioni, sarebbe un’occasione imperdibile. Si tratta di una rivoluzione culturale pacifica, che non intende estromettere a priori la religione dal percorso di crescita del giovane, ma che la sfida a definire nuove soluzioni e campi di studio, che superino l’interpretazione della parola di Dio secondo le categorie sopra citate e francamente non più condivisibili. È parimenti auspicabile destituire la scienza, causa dell’angoscia e dell’errore più abissale poiché considera l’uomo come mera materia contingente, dallo statuto di verità assoluta.
Nel deficit simbolico e nella carenza di vitalità spirituale che caratterizza il nostro orizzonte socio-culturale, è auspicabile creare delle narrazioni (Campione, 2012) che permettano ai bambini di oggi – e agli adulti di domani – di abitare la vita di tutti i giorni nella consapevolezza del limite, del mistero, e nella capacità di sperare (Bormolini, 2015).
Il teologo Mancuso è a mio avviso un esempio di questo tentativo. Per secoli in Occidente la fondazione del pensiero di Dio è stata attuata a partire dalla Chiesa e dalla Bibbia. Egli intende parlare di Dio a partire dall’io, collocando un altro fondamento, molto più intimo, del tutto interno a noi stessi, giocando la partita della vita e del suo senso come un incontro tra io e Dio, il cui nucleo centrale si struttura sul sentimento del Mistero che circonda la vita.
La spiritualità ha a che fare con l’orizzonte e l’ermeneutica del Mistero: esso va contemplato, non risolto come fosse un problema a cui cercare una soluzione, né svelato ad ogni costo. Il Mistero non è dato dall’impoverimento dell’esperienza vitale, come qualcuno superficialmente ritiene, spiegandone l’origine sulla base dell’ignoranza o dell’oppressione e riducendolo a enigma. Chi pensasse così, tenga presente la frase di Niels Bohr, padre della meccanica quantistica: “Ci sono due tipi di verità: le verità semplici, dove gli opposti sono chiaramente assurdi, e le verità profonde, riconoscibili dal fatto che l’opposto è a sua volta una profonda verità”.
Quando si crede in un orizzonte trascendente, se si analizza ciò sul piano psicologico, si presentano sempre le strutture e i contenuti di una proiezione e vi è sempre il sospetto che sia così. Non è, tuttavia, il dato di fatto della proiezione a decidere se l’oggetto cui essa si riferisce esista oppure no. E’ possibilissimo che al desiderio di Dio corrisponda una realtà di Dio. E perché non dovrei desiderare che con la morte non sia tutto finito, che la mia vita e la storia dell’umanità abbiano un senso, che, in breve, Dio ci doni la vita eterna? (H. Küng, 2015). E’ un po’ quello che dice anche Francesco Campione, uno dei maggiori studiosi contemporanei del processo del morire: “Siccome è un mistero, siccome non sappiamo, possiamo continuare a desiderare il Bene come sempre”, chi ce lo impedisce?
Quello che voglio dire è che “Sulla strada del mistero si salvano la vita e la morte, invece fuori di essa la morte diventa brutale e la vita insensata: dove c’è realmente una fine, di per sé, non c’è alcun mistero. Ma dove c’è mistero non c’è quella che chiamiamo “fine”. C’è piuttosto una sovrabbondanza di realtà che non riusciamo a scandagliare. Così si deve dire che la morte è mistero, mentre non siamo autorizzati a dire che sia la fine”. (Mancini, 2010)
Alla luce di queste considerazioni, ritengo non sia più possibile porre la questione in termini dualistici tra chi crede e chi non crede: in ognuno di noi c’è sia il credente che il non credente, come ebbe a dire il Card. Martini.
Norberto Bobbio, si definì sempre lontano dalla fede. In un testo particolarmente delicato però, denominato Ultime volontà e pubblicato sulla “Stampa” il 10 gennaio 2004, all’indomani della sua morte, il grande filosofo torinese giunse a scrivere: “Non mi considero né ateo né agnostico.
Come uomo di ragione, non di fede, so di essere immerso nel mistero che la ragione non riesce a penetrare fino in fondo, e le varie religioni interpretano in vari modi”.
In conclusione, affrontare la vita, le emergenze, le sofferenze, alla luce della spiritualità significa vivere sapendo di non sapere, e proprio per questo poter sperare.
“Si può giungere a chiamare “padre” il senso ultimo del mondo. E’ un’illusione o l’approdo alla realtà suprema? Nessuno può rispondere con certezza intellettuale, può solo argomentare a partire dal sapore della sua vita e dai frutti che essa porta” (Mancuso, 2017).
Padova, 3 maggio 2020
Bibliografia: N. Bobbio, Ultime volontà, in N.Bobbio, Etica e politica, Milano: Mondadori, 2009; N. Bohr, My Father, New York: John Wiley, 1967; F. Campione, La domanda che vola, Bologna: EDB, 2012; H. Küng, Morire felici? Lasciare la vita senza paura, Milano: Rizzoli, 2015; R. Mancini, Il senso della fede, Brescia: Queriniana, 2010; V. Mancuso, Io e Dio, Milano: Garzanti, 2011; V. Mancuso, Il coraggio di essere liberi, Milano: garzanti, 2016;
V. Mancuso, Il bisogno di pensare, Milano: Garzanti, 2017; C.M. Martini, Le cattedre dei non credenti, Milano: Bompiani, 2015; I.Testoni, G. Bormolini, E.Pace, & L.V. Tarca, Vedere oltre. La spiritualità dinanzi al morire
nelle diverse religioni. Torino: LINDAU, 2015; I.Testoni, L’ultima nascita. Psicologia del morire e Death Education. Torino: Bollati Boringhieri, 2015; A. Pangrazzi, Superare il lutto. Trento: Erickson, 2011; P. Hadot, Esercizi spirituali e filosofia antica. Torino: Einaudi (ed. orig. 2002); V. Frankl, Dio nell’inconscio. Brescia: Morcelliana., 2014; L.Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicum 6.52 (1921), in Tractatus logico-philosophicum e Quaderni, Torino: Einaudi, 1998.
STATISTICHE
di Carlo Saletti, storico e regista teatrale
I dati complessivi della giornata vengono diramati alle ore 18 del pomeriggio. A tenere il conto è la Protezione civile. La tabella persiste come un fotogramma fisso per qualche decina di secondi sui monitor dei nostri televisori. Fornisce il quadro statistico – il numero totale dei contagi, il numero dei nuovi casi, il numero dei guariti, il numero dei deceduti. Qualcuno si è abituato a considerarla alla stregua di un bollettino di guerra.
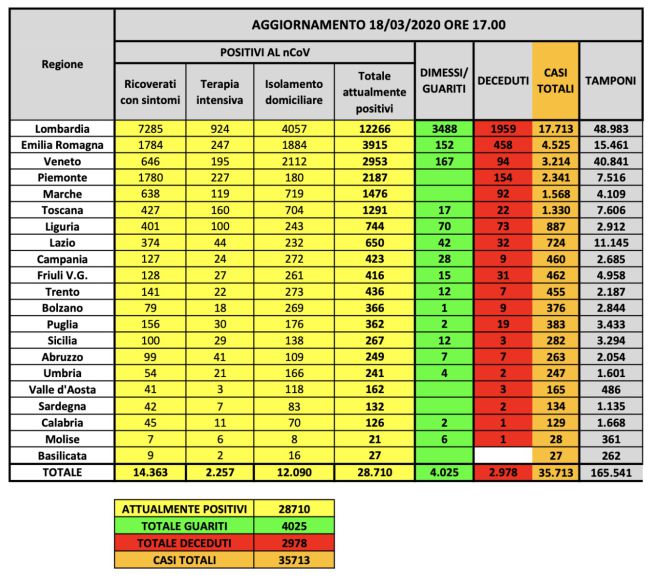
Intervistato nel 1984 da Marco Vigevani, Primo Levi ammetteva che vi era una carenza nella sua testimonianza sull’esperienza vissuta nel Lager: “Manca un dato di terribile peso”, diceva, “quello quantitativo”. Levi non aveva cessato di testimoniare, e lo avrebbe fatto sino alla fine, sugli individui singoli che aveva conosciuto e di cui aveva udito spegnersi il respiro. Non era riuscito a parlare, invece, della totalità dei sommersi.
A nome della solitaria moltitudine parlano i numeri. A ciò servono le cifre e le percentuali. Solo le statistiche vanno oltre il singolare l’unità), per comunicarci l’ampiezza e la totalità le decine). Di fronti alla singolarità ci commuoviamo, di fronte alla pluralità fremiamo. Sta in ciò la catastrofe: nel far coesistere il singolare e il plurale.
Custoza, 22 marzo 2020
Bibliografia. Carlo Saletti, Pensare il crimine di massa. Sette tipi di ambiguità, 2019, inedito; Marco Vigevani, Le parole, il ricordo, la speranza, in Primo Levi, Conversazioni e interviste, 1963 – 1987, a cura di Marco Belpoliti, Einaudi, Torino, 1997
STATO DI EMERGENZA
di Roberto Capuzzo, avvocato
Lo Stato Di Emergenza per coronavirus è stato dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 “..vista la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC – Public Health Emergency of International Concern) dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 30 gennaio 2020”.
Nel provvedimento sono indicati i caratteri essenziali dello Stato di Emergenza:
- durata di sei mesi fino al 31 luglio 2020;
- stanziamento per i primi interventi di 5 milioni di Euro;
- per l’attuazione degli interventi si provvede con ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile “in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico”.

La prima disposizione di legge che ha introdotto lo Stato di Emergenza è l’articolo 5 della L. 24/2/1992 n. 225 con la quale è stato istituito il “Servizio Nazionale della protezione civile” che il recente Codice della protezione civile (Decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1) ha definito come “il Sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall’insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo”.
In considerazione della gravità dell’incombente rischio sanitario, la Delibera del CdM 31/1/2020 ha espressamente richiamato gli articoli 7 e 24 del Codice della protezione civile.
L’art. 7 distingue tre tipi di interventi emergenziali dei quali il più grave è “l’emergenza di rilievo nazionale” che richiede “immediatezza di intervento che deve essere fronteggiato con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo”.
L’art. 24 dispone che lo Stato di Emergenza di rilievo nazionale è deliberato dal Consiglio dei Ministri ed inoltre attribuisce poteri di ordinanza alla Protezione civile.
Se non attuata con la massima attenzione, la normazione emergenziale potrebbe rivelare serie criticità per l’ordinamento giuridico in quanto essa introduce norme in deroga alle leggi vigenti senza alcun effettivo controllo da parte del Parlamento. Le ordinanze del Capo della protezione civile, quelle regionali e comunali e i Decreti Ministeriali (DM), tra i quali sono ricompresi i Decreti del Presidente del Consiglio (DPCM), non sono infatti soggetti a controllo, né preventivo né successivo. I decreti legge (d.l.), se non convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione, decadono e gli effetti già prodotti vengono travolti sin dall’origine, con evidente compromissione del principio di certezza del diritto. Al fine di scongiurare rischi di debordamento della normativa emergenziale rispetto alle norme ordinarie, si impone quindi lo stretto controllo sul contenuto dei provvedimenti di urgenza, il più ampio coinvolgimento delle opposizioni e la piena operatività del Parlamento.

Esempi di approfittamento dello Stato di Emergenza per imprimere svolte autoritarie sono dati dalla Polonia di Kaczynski e l’Ungheria di Orban. Quest’ultimo, in particolare, approfittando della maggioranza assoluta, il 30 marzo ha capitalizzato politicamente l’emergenza Covid-19, facendosi attribuire dal Parlamento pieni poteri senza limiti temporali: potrà abrogare leggi già votate in precedenza, non potranno tenersi elezioni finché queste misure resteranno in vigore, è prevista la detenzione da uno a cinque anni per chi diffonde notizie false od ostacola gli sforzi delle autorità nel controllare la pandemia. In concreto, ha posto sotto il controllo governativo il funzionamento dei media.
Non è questo certamente il pericolo italiano ma è opportuno mantenere alta l’attenzione sull’uso dei poteri straordinari conferiti dalle disposizioni speciali al Governo nel tempo dello Stato di Emergenza.
Verona, 3 aprile 2020
STORIA ON LINE
di Antonella Tiburzi, docente di didattica della storia, unibz
Oltre 1,5 miliardi di studenti e giovani in tutto il pianeta sono colpiti dalla chiusura di scuole e università a causa dell’epidemia di Covid-19 in una dimensione senza precedenti nella storia, pertanto la didattica digitale di storia, ma ovviamente anche di altre discipline, svolge il ruolo di facilitare le opportunità di insegnamento e apprendimento inclusivo per studenti di ogni ordine e grado. Per contribuire a garantire la continuità nelle attività di istruzione e formazione è stata pertanto organizzata una vasta gamma di materiali didattici disponibili online. Nella didattica della storia online si forniscono molteplici risorse digitali, gratuite e utili sia ai docenti che agli studenti (Classroom Drive), che favoriscono l’intervento delle tecnologie volte a dare sostegno all’insegnamento, all’apprendimento e infine anche alla ricerca (Edmodo, Schoology).
Nell’insegnamento della storia, le fonti come quelle materiali, l’iconografia, le mappe storiche, i diagrammi e le statistiche, sono essenziali allo sviluppo dello studio, ma purtroppo l’usura del tempo rendono la documentazione non sempre accessibile e usufruibile sia dal docente che dallo studente pertanto spesso si rischia di trattare un argomento senza la necessaria rappresentazione del luogo o dell’evento. La tecnologia applicata alla didattica nelle classi di storia di ogni ordine e grado, permette invece l’accesso, dunque lo studio e la ricerca, a tutta questa documentazione, facilmente riproducibile e consultabile, in modo duraturo, vivace e inter-attivo, con gli studenti da casa o da qualsiasi altro posto ci sia una connessione. Se nelle attuali contingenze non si possono visitare i luoghi della storia, l’insegnamento della storia online ci permette di “raggiungere” e spiegare uno spazio attraverso soluzioni pedagogiche interattive. Ovviamente non si tratta della stessa esperienza che si avrebbe dal vivo, ma tuttavia si può ricorrere a delle metodologie che usano la tridimensionalità dell’area permettendo allo studente di “entrare” in uno spazio storico del passato. In questi giorni infatti anche gli archivi e i musei, hanno “aperto” virtualmente le loro sale facilitando moltissimo l’apprendimento attivo, lo sviluppo dell’osservazione, l’indagine, l’analisi e il confronto. Ogni scuola o ateneo dovrebbe dunque dotarsi di una piattaforma di apprendimento online in cui inserire i musei o luoghi storici virtuali da tutto il mondo, in modo perenne.

L’insegnamento di storia al tempo del Covid19, ci dovrebbe far riflettere sugli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione. Le lezioni del docente via Teams (spesso per ambiti universitari), Meet, Zoom, Vimeo e altre piatteforme[1] possono essere organizzate, programmate, reiterate e pubblicate in specifiche unità didattiche in diversi formati, con ampie sezioni di immagini, tabelle, schemi e fotografie d’epoca. L’uso dei forum online, che è ampiamente applicato nella didattica della storia nel mondo anglosassone, si è reso particolarmente vantaggioso in questo periodo per gli educatori di storia, dal momento che gli studenti si sono sentiti coinvolti in dibattiti, utili inoltre allo sviluppo del loro senso critico. Con l’aumento dei forum online, la discussione ha oggettivamente trovato più spazio rispetto alla classe tradizionale e ha permesso agli studenti di sviluppare la cittadinanza digitale. A questi strumenti si possono aggiungere questionari (Drive, SurveyMonkey) a scelta multipla o aperti a cui gli studenti possono rispondere autonomamente, sotto forma di testo, immagine o video, verificando loro stessi gli eventuali progressi e condividendoli perfino in ambito europeo attraverso la straordinaria piattaforma European E-Twinning.
La storia online è una innovazione che fornisce oggi una formazione ampiamente riconosciuta e certificata attraverso strumenti più efficaci nel tempo. L’impiego dei webinar è molto utile quando si tratta di lezioni dirette in cui gli studenti o i partecipanti possono interagire in tempo reale con domande, questioni, affermazioni e discussioni. L’uso di foto storiche animate[2] centrano l’attenzione dello studente e non rischiano lo scolorimento mentre l’evidenziazione di parole in box colorati stimolano l’approccio mnemonico, l’utilizzo di linee del tempo o infografiche interattive, in cui le date e i dati si generano in modalità continua, sollecitano la percezione del periodo e infine l’esposizione di un incontro virtuale con un personaggio collocato nel suo luogo storico (campo di battaglia, lager o un palazzo) illustra ampiamente la simbiosi dalla geostoria. La formazione didattica digitale e metodologica dovrebbe essere dunque presa seriamente in considerazione perchè rappresenta la premessa al vero e necessario cambiamento dell’istruzione nel nostro paese.
Merano (Bz), 12 aprile 2020
Sitografia. Presso il sito dell’Unesco è possibile trovare molte soluzioni alle proprie necessità didattiche: ttps://en.unesco.org/covid19/educationresponse/solutions;
Stronzate
Harry G. Frankfurt On Bullshit, , Princeton Press, 2005
di Luciano Butti, docente di diritto ambientale unipd
“Il coronavirus è stato creato in laboratorio, è dimostrato che è possibile”.
“Il cambiamento climatico non è un problema, perché le temperature aumentarono anche nel Medio Evo”.
“I vaccini sono nocivi alla salute, infatti contengono alluminio, notoriamente pericoloso”.
Queste tre affermazioni sono stronzate, nell’accezione che di questo termine dava Harry Frankfurt, per molti anni docente di filosofia a Yale e poi a Princeton.
Secondo Frankfurt, ciò che caratterizza le stronzate non è la loro falsità. E’, invece, il completo e deliberato disinteresse di chi le diffonde per la verità o falsità del contenuto dell’affermazione. Chi diffonde stronzate spesso non sa se siano vere o false e mira essenzialmente ad impressionare il proprio pubblico. Egli è più pericoloso del bugiardo, il quale ben conosce la verità.
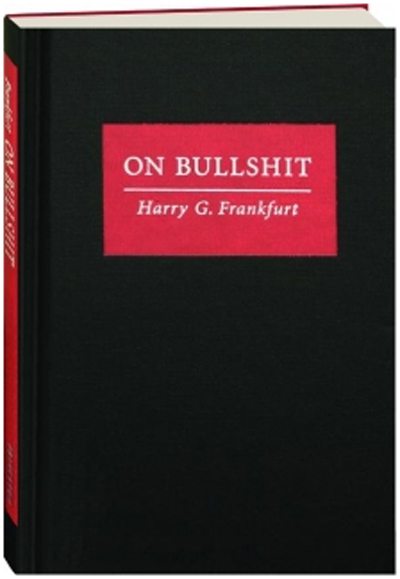
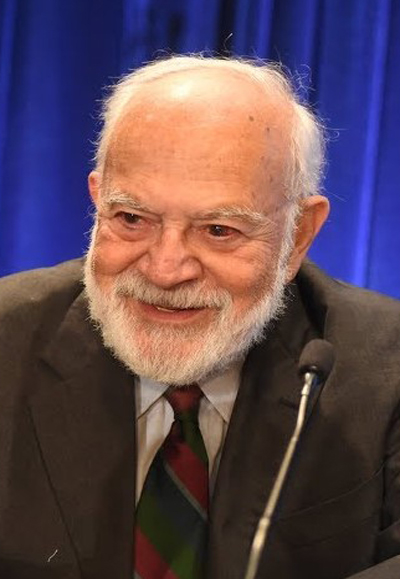
La severa pericolosità di qualsiasi “stronzata” consiste nel diffondere l’idea che ogni argomentazione sia legittima, alla sola condizione che sia istintivamente persuasiva. Se ripensiamo alle tre affermazioni iniziali, possiamo capire che si tratta di tipiche stronzate. Tutte si avvalgono di un particolare che contiene qualche elemento di verità, ma ne traggono conseguenze completamente arbitrarie. L’ingegneria genetica può infatti molto, ma non vi è alcuna evidenza che il Coronavirus sia stato creato in laboratorio, anzi vi è evidenza contraria. Nel Medio Evo effettivamente la temperatura era in molte parti del pianeta più calda di quella attuale, ma ciò è perfettamente spiegabile e non inficia affatto la realtà del riscaldamento globale in corso né i pericoli che esso comporta. I vaccini possono infine contenere tracce di metalli, ma in quantità assolutamente innocua. Francesco Bacone aveva già capito tutto: “L’intelletto umano, quando trova qualche nozione che lo soddisfa, … perché avvincente e piacevole, conduce tutto il resto a convalidarla e a coincidere con essa”. Speriamo che il virus, facendoci comprendere l’importanza della scienza e dei dati, ci serva almeno, in futuro, a liberarci dalle peggiori stronzate.
Verona, 7 aprile 2020
SUPERMERCATO
di Claudio Tombari, consulente di formazione
La nozione di supermercato, ovvero la modalità di spesa impersonale, distanziata, non quotidiana, in situazione collettiva, quale acquisizione sociale è tutt’uno col Novecento. Il primo supermercato italiano comparve a Milano, in viale Regina Giovanna nel 1957 si chiamava Supermarket, nome e format importato dagli USA. Dai 23 del 1958 i supermercati divennero 609 nel 1971 e quasi duemila negli anni Ottanta, affiancati ben presto dagli ipermercati. Tutto sommato, il supermercato sembra in qualche modo resistere anche agli sconvolgimenti e ai forzati cambiamenti di abitudini sociali che questa brutta storia del Covid-19 sta portando con sé.

Ai tempi del Covid-19 utilizzare e frequentare il supermercato non è più così semplice però: da una certa data di marzo le nuove norme ci impongono di andare in quello più vicino a casa e comunque mai fuori del proprio comune, comprimendo in questo modo la nostra libertà di scelta sul libero mercato. E andarci significa mettersi in fila con altri esseri umani a debita distanza e aspettare disciplinatamente il proprio turno. Strane sensazioni ci accompagnano: si compie una sorta di dovere del consumo necessario, ma in qualche modo si perde quel che di contemplativo e curioso c’era, prima di ora, nel perdersi nelle corsie. E, sotto sotto, anche con qualche timore dal momento, come si sente spesso dire, i supermercati, insieme alle residenze per anziani e alla famiglia, paiono essere tra i luoghi più favorevoli per il passaggio del virus.
Alternative possibili all’andare fisicamente al supermercato: l’uso dei negozi di vicinato e la spesa online con consegna a casa o (come assicura un noto super milanese in corso Milano) con ritiro passando in auto. Tra marzo e aprile è cresciuto certamente l’uso dei negozietti di vicinato ma non è certo esploso; anche perché ormai non sono molto numerosi. Con la sospensione dei mercati all’aperto della Coldiretti, i negozi di frutta e verdura hanno visto più clienti, come anche le ormai poche macellerie restate in città.
Certo questa brutta storia del Covid-19 ha fatto emergere atteggiamenti regressivi e ataviche fami. Le percentuali boom di alcuni prodotti di primaria importanza (+59% della pasta di semola, +50% delle uova, +47% del latte, +83% per farine e legumi secchi, +82% per la carne in scatola, +72% per i fagioli conservati) fotografano una “spesa di guerra”, sottolinea Coldiretti nell’analisi effettuata nel periodo 8-15 marzo. Curioso e sintomatico è l’impennata del consumo di lievito di birra (+70%), che segnala un generalizzato ritorno ai fornelli conseguente all’accresciuta disponibilità di tempo per cucinare. Forme di forzata regressione nell’impiego del tempo, verso il far da sé e l’autoproduzione dei mezzi di sopravvivenza. Con conseguente fiato alle trombe di immaginari pauperisti e teorizzazioni decresciste, preindustriali e di ritorno alla natura. Va messo in conto anche questo, nei costi della pandemia. Una sorta di ritorno ai bisogni primari, ai racconti delle nonne (o mamme) durante la guerra e al feticcio del cibo da procurarsi.
Dal secondo dopoguerra in avanti la percentuale di spesa per il cibo sul totale dei consumi è sempre diminuita: un classico indicatore di accresciuto benessere. Nel 1952 da un’indagine Doxa su 215 famiglie milanesi, risultava che le famiglie censite come ‘povere’ dedicavano all’alimentazione il 65% del proprio reddito. Poi la situazione è cambiata negli anni.
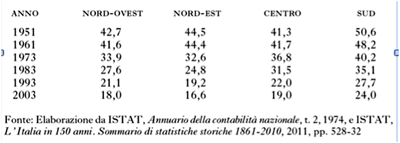
Percentuale di spesa per il cibo sul totale dei consumi
Anche nel decennio 2009-19 la spesa alimentare è passata da 466 a 457 euro mensili per famiglia (-1,9%), confermando la tendenza, ma rallentando la discesa.
Ma al di là di tutto, il supermercato, quale icona e simbolo del moderno, ha mantenuto il suo ruolo e il suo fascino e i più evoluti hanno introdotto interessanti innovazioni. C’è stato – e c’è tuttora – un vero assalto alle consegne online dei supemercati, con il risultato di una grande e diffusa frustrazione. Una sorta di festival delle promesse mancate e del velleitarismo: non sono riusciti a organizzare le consegne in tempi umani e in buona sostanza hanno illuso e deluso. Anche se probabilmente la spesa online sarà il futuro. Sicché vien da chiedersi quale potrà essere il futuro del supermercato. E in particolare quali saranno i modi futuri della spesa per il cibo.
Grandi supermercati dentro grandi centri commerciali, supermercati medi, supermercatini di prossimità? Pensiamo alle librerie: hanno gradatamente chiuso, sostituite da Amazon e IBS e le poche ancora aperte sono diventate luoghi di incontro, piccoli cenacoli di cultura o bar con annessa libreria. Per il consumo alimentare e più in generale per i prodotti di sopravvivenza potrebbe replicarsi il modello: dopo Covid-19 è presumibile un grande incremento della spesa online con consegna a casa o ritiro in auto tipo drive-in, con grande nuova occupazione di nerd e fattorini. Sicché l’ora che spendo oggi al super sarà un lontano ricordo. Ma contemporaneamente potrebbero svilupparsi supermercatini di prossimità (a volte anche con orari lunghi fino a 24 ore su 24) con annesso bar e tavola calda (un primo esempio è l’ESSE di corso Italia a Milano). E tutto ciò potrebbe convivere con forme cooperative a chilometro zero, in modo particolare per frutta, verdura e alimenti di nicchia, destinati a target choosy e/o in qualche modo alternativi.
Verona, 11 aprile 2020
TAVOLO
di Gian Arnaldo Caleffi, architetto
Ogni abitazione ha almeno un tavolo: per pranzare, per cucinare, per giocare, per appoggiare.
La struttura è realizzata con diversi materiali, dal legno, al ferro, all’acciaio, così come diversi sono i materiali del piano, dal legno al marmo, al vetro.
Altrettanto diversi sono gli stili del tavolo, dal rococò all’impero, dal rustico al “moderno”, così come diversi sono i colori, dal bianco al legno naturale, dal legno tinto alla trasparenza del vetro, al colore naturale del marmo.
Diverse sono le finiture, dal lucido all’opaco, dal verniciato al laccato.
Ogni tavolo ha una diversa forma, rettangolare, quadrata, rotonda ovale, ad anche una larghezza e una profondità o un diametro diversi, ma tutti i tavoli hanno una caratteristica in comune: l’altezza.
L’altezza di tutti i tavoli va dai 70 ai 75 centimetri, con pochissimo scostamento in più o in meno. Che poi è la stessa altezza delle scrivanie degli uffici.

Ecco la prima scoperta del neofita dello smart working improvvisato in tempo di virus: su un qualunque tavolo di casa posso appoggiare il portatile ed iniziare a lavorare.
Facile no?
Niente affatto!
Perché in smart working vanno il marito, la moglie e i figli, tutti con l’esigenza di un tavolo e di una sedia, ma anche di un po’ della tranquillità necessaria per la concentrazione. Perché scrivere mentre un altro familiare è impegnato in una conference call, o sta ascoltando una lezione, non è così semplice.
Chi vive in una casa grande ha a disposizione tante stanze e tanti tavoli, ma chi vive in uno di quei miniappartamenti pensati per la pura abitabilità del dopolavoro e del doposcuola non ha tante scelte.
L’architettura contemporanea ha affinato gli spazi dell’abitazione per non far mancare nulla di ciò che serve per vivere, ha ridotto gli spazi e, quindi, i costi, ma non ha contemplato lo spazio per il lavoro. L’abitazione borghese ottocentesca prevedeva lo studio corredato dello scrittoio provvisto di un calamaio per intingere la penna.
Poi il Movimento Moderno ha studiato l’existenzminimum e tutto si è ridotto all’ essenziale, abolendo il superfluo. E col superfluo se ne è andato lo studio col suo scrittoio. A volte nella stanza dei ragazzi è rimasto un piccolo tavolo per studiare, ma è sempre ingombro di oggetti.
E allora si scopre che le abitazioni moderne non sono fatte per lavorare, ma solo per abitare. Se in prospettiva dovremo convivere coi virus sarà necessario adeguare le case in cui viviamo, servono nuove tipologie, nuovi spazi, maggiori dimensioni: ci sarebbe tanto lavoro da fare.
Servirebbero anche tanti soldi.
Verona, 22 marzo 2020
TEMPO
di Maria Paola Fregni, docente
«Come nessun tempo mi appartiene/eppure sempre indico il tempo,/così nessun tempo sicuro/ appartiene a te o viandante» Torre dell’Orologio di Fanano (20 ottobre 1609), con incisa la suggestiva iscrizione sopra riportata, qui nella versione in italiano corrente. Un’immagine presa da un locus amoenus, di estiva villeggiatura appenninica. Ellissi spazio-temporale: un anonimo pellegrino camminatore, homo viator del ‘600 e una donna viaggiatrice del Pianeta in epoca globalizzata al tempo del Coronavirus. A questa immagine onirico-simbolica e alla breve ma incisiva quartina della torre, affiderò dunque alcune schegge di riflessione sul tempo che stiamo vivendo dentro questo imperversante e imperante Coronavirus. Così, l’orologio della torre parla ancora, facendosi interprete dell’arcano mistero del Tempo e dell’andare. Assurge a entità personificata e, pur scandendo precisamente il tempo, colloca chi peregrina fisicamente o con la mente, più che mai ora, durante il lockdown, in una dimensione metatemporale, in una imprecisata e soffusa zona di sospensione del tempo. Pigramente, posto sulla torre antica, l’orologio assolve la sua funzione di definire il kronos, nella forma umana che del tempo è stata data, ma dice che nessun tempo gli “appartiene”. Esso sta lì, ad osservare e a scandire il panta rei del divenire, il tempo che fluisce ineluttabile. Così anche il viandante, l’homo viator, che riassume la condizione esistenziale spazio-temporale di noi tutti, pellegrini in cammino, non è padrone assolutamente di alcun tempo. Anzi deve fare i conti, come ammonisce l’iscrizione, con una condizione di insicurezza, di fragilità e di precarietà esistenziale.

In questo periodo, appunto, ci sorprendiamo a cercare di trovare spazi di senso meno incerti, mentre il dubbio o l’ansia serpeggiano nei meandri della nostra mente. Dobbiamo pertanto fare i conti con la nostra condizione umana costitutivamente transeunte, così come con la sensazione di essere entrati in una sorta di mondo parallelo, per adattarci al quale occorrono forme nuove, nuovi paradigmi con cui ridefinire una realtà che si profila assai nebulosa. Ed ecco allora la profonda attualità della torre, della sua iscrizione incisa, del suo orologio. Ed ecco noi, uomini e donne del 2020 che andiamo, metaforici viandanti e camminatori. Pur rimanendo chiusi in casa, avanziamo con sentimenti in bilico tra ansia e speranza, in attesa dell’ignoto, avidi e storditi di notizie massmediatiche o di clamori virulenti dei social che rischiano di narcotizzarci, dentro ad una spirale di confuso sonnambulismo. Più che mai in tempo di Coronavirus, il senso di transitorietà, di finitudine e di precarietà sono le categorie che ci appartengono in quanto essenzialmente viandanti: «nessun tempo sicuro appartiene al viandante». Non siamo i padroni del Tempo. Questo ci ricorda, dal 1600 a Fanano, la torre dell’orologio; questo ci ricorda, oggi, con forza inaudita, ovunque nel mondo, il temibile virus. Per non essere sopraffatti, per uscirne vincenti, però, il tempo del Coronavirus può e deve essere visto come una grande occasione. Un tempo in cui leggere la precisione dell’amore, dei nostri affetti, delle nostre relazioni umane che ne tessono le trame, o, come direbbe Levinas,un tempo come relazione intersoggettiva del Soggetto con Altri. Un tempo in cui ci si sente forse più soli, ma paradossalmente anche più uniti al Tutto dell’Universo e a tutti gli abitanti del Pianeta. Un tempo percepito e vissuto in modo anche archetipico, junghiano, viscerale. Tenendo presente che dell’archetipo vi è la realtà del passato, presente e futuro, questo nostro tempo può essere letto come costitutivo della nostra più profonda identità; un tempo di verità nel quale possiamo cercare e, forse, trovare la consapevolezza di noi stessi e la nostra più compiuta evoluzione.
Un tempo ricco di senso, di intuizioni, di sensazioni, di emozioni, di logica, ma anche di grandi passioni e di impegno che non si esaurisce più, come prima, in una serie di azioni compiute in un divenire vorace che ci fagocita. Un tempo in cui si può scegliere la meravigliosa intensità del dono della vita trasponendola nell’istante e nei piccoli gesti quotidiani per scoprirne la bellezza e tornare ad abitare poeticamente il mondo e noi stessi. «Nos sumus tempora» (Noi siamo i tempi), dice S.Agostino.
Siamo noi, gli umani del tempo del Coronavirus, che, partendo dall’improvvisa, inattesa e traumatica riscoperta della nostra fragilità, ricostruiremo insieme, ripensandoli e ridisegnandoli con fiducia, i nuovi spazi geografici che verranno e il nuovo tempo che verrà.
Modena, 29 aprile 2020
TENDENZE SECURITARIE
di Ivan Cenzi, Bizzarro Bazar
Il Covid-19 è manna dal cielo per le tendenze securitarie, ed è facile vedere come le misure emergenziali siano sovrapponibili all’ideologia del Decoro che ha informato le ultime decadi in Occidente, innervandosi sottotraccia verso un sistema di controllo e di marginalizzazione del diverso. L’ideale di sicurezza, peraltro, è pensato per non essere mai raggiunto: quando potremo ragionevolmente ritenerci al sicuro da ogni minaccia? Ovunque il contagio è inquadrato come un problema di sicurezza nazionale. La reazione della polis al virus si fonda immancabilmente sulla metafora marziale, sulla minaccia delle invasioni barbariche. Il virus ci impone una normalizzazione dei comportamenti: chi dalla Norma si discosta, è perseguibile anche con mezzi armati. In molti lo vanno ripetendo: aspettiamoci che queste misure – seppure allentate o riproposte a intervalli di tempo più o meno regolari, col pretesto di scongiurare nuove epidemie – divengano una realtà quotidiana. Certo c’è chi auspica un costante stato d’allerta e una popolazione censita e parcellizzata: come ha mostrato Foucault, la peste piace a chi sogna una società militare.

Il secondo cardine della narrativa dominante è la salvaguardia di un altro valore imprescindibile, la salute. Nel teatro di una cultura in cui i veri scandali sono vecchiaia, infermità e morte, il virus incarna l’antagonista perfetto. Affinché il rimosso rimanga tale, tutti devono compattarsi per far sparire al più presto l’insidia, rafforzando in coro il mantra: la salute prima di tutto. Ma davvero la salute viene prima di tutto? Prima dell’emozione e del pensiero? Della poesia, della rabbia, dell’amore o della sete di trascendenza? Le pagine più toccanti nella vicenda del primate homo sapiens (perfino quelle care ai nostalgici dell’eroismo bellico) sono tutte storie di abnegazione della dimensione fisica, sono storie meta-fisiche. «Proteggete la malattia», scriveva in Nova Express William S. Burroughs, «proteggere la società dalla malattia deve diventare un reato.»
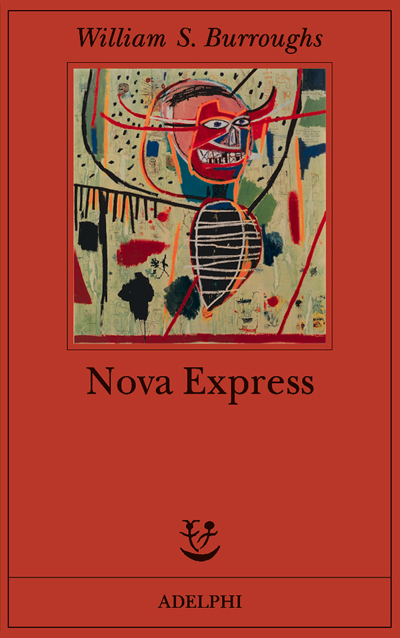
Per Burroughs il morbo è essenziale al Controllo, che ne trae profitto; una «cura vera del problema sociale» sarebbe «pericolosa per la società». Ma vi è anche una dimensione sovversiva dell’essere malati, cioè etimologicamente “mal atti”, non adatti, disadattati rispetto agli standard imposti dal consorzio sociale.
Una cultura priva di malattia non è una cultura sana: una società senza depressi, drogati, mistici o pazzi dall’occhio spiritato, senza cellule cancerose e rivoltose – insomma una società senza dèmoni, è una società morta. Schiava del tetro ordine che vorrebbe l’uomo ridotto alla sola misura fisica, dell’imperativo categorico mens sana. I corpi “mal atti”, improduttivi e osceni, sono tabù. Allora «proteggere la malattia» può diventare una forma di ribellione: significa smascherare il gioco del Controllo, abbattere i cancelli dorati della Nazi-Disneyland che ci vuole sorridenti e selfiegenic, gettare la zavorra, ammettere l’evidenza del terrore e del mistero tutto attorno. Dio ci scampi dall’essere sempre sicuri e sani. Non è una resa, perché non c’è nemico a cui arrendersi: forse la carne difforme è più autentica di quella conforme. Il virus è vita.
Roma, 10 aprile 2020
Bibliografia: Wolf Bukowski, La buona educazione degli oppressi. Piccola storia del decoro, Edizioni Alegre 2019; Michel Foucault, Storia della follia, Rizzoli 2011; William S. Burroughs, Nova Express, Adelphi 2008.
TESTIMONI SCOMPARSI
di Carlo Benfatti, storico e giornalista
Il Coronavirus ha fatto strage degli anziani ricoverati nelle RSA, negli ospedali, nelle case private. Un lutto immenso che ha lasciato le famiglie nella disperazione con l’aggravante di non essere stati vicini ai loro cari negli ultimi momenti. Ora è in corso una generale reazione che si concretizza nell’esporre denuncia contro chi aveva il compito dell’assistenza e della salvaguardia della salute dei ricoverati. Infatti sono già attivate investigazioni in tutti gli ospizi regionali per individuare responsabilità e soprattutto carenze di strumenti sanitari. Si stima che fra i 26 mila deceduti per l’epidemia la maggioranza fossero persone anziane, spesso con altre patologie. Da più parti si è posto in risalto la tragedia di queste perdite che hanno sottratto alla società non solo l’affetto confortante di familiari e parenti, ma anche la perdita di un patrimonio di esperienze di via di cui i defunti erano portatori.
Senza dubbio questi anziani fin che stavano fuori o anche protetti nelle case di riposo, hanno contribuito a dare buoni consigli ai propri congiunti, frutto ovviamente delle buone o cattive esperienze vissute, insomma una cultura di vita indispensabile per sostenere figli, nipoti e parenti alle prese con una quotidianità sempre più problematica. Anche i nonni o le nonne più rinchiusi in se stessi, o poco propensi a raccontare il proprio vissuto per troppo pudore, qualche volta avranno accennato ai loro trascorsi, a certe difficoltà superate, magari col proposito di confortare familiari posti di fronte a determinate emergenze.
In generale, ne siamo sicuri, questi racconti di gioie e dolori, di successi e disinganni spesso sono stati profferiti con senso di protagonismo e anche con un certo narcisismo, propri di coloro che hanno agito con coraggio e determinazione superando ostacoli, incomprensioni, miserie economiche di ogni tipo. E’ la tipica euforia di chi racconta il proprio passato irto di situazioni difficili ma brillantemente risolte. Tale atteggiamento viene riscontrato specialmente nei ricordi di guerra, della deportazione e della lotta partigiana. Viene pure rievocata la situazione precaria del dopoguerra, quando si presentava allettante la migrazione verso le città del nord.

Ci si chiede: questo patrimonio di vita vissuta, di esperienze di ogni tipo sono andati tutti perduti col decesso prematuro a causa del Coronavirus? Fino a che punto è avvenuto il passaggio del “famoso testimone”? L’epidemia senza dubbio l’ha interrotto, però siamo convinti che la “trasmissione” in qualche modo era cominciata prima, tanto è vero che i familiari pur immersi nel dolore della scomparsa, non possono non ripensarla o anche rievocarla quasi in ossequio al loro caro estinto. Si è propensi a credere che quel bagaglio i esperienze di vita, ormai introiettato, continua a sussistere, nei pensieri, nei gesti, nel modo di comportarsi dei familiari. Si sa che gli anziani ripetono spesso il loro vissuto, piacevole o spiacevole che sia a tal punto di apparire noiosi, ma certe valutazioni, certe espressioni in lingua o vernacolo, vengono riuditi mentalmente dai congiunti dando loro forza e coraggio nell’affrontare i disagi e le difficoltà del quotidiano.
I più loquaci di questi anziani che hanno avuto il desiderio di comunicare i casi della loro vita, alla fine quale è la sostanza della rievocazione? Fondamentalmente è l’uso della ragione, della capacità critica dinnanzi ai problemi, entrambe dettate dall’esperienza pratica. Quella praticità che purtroppo manca alle nuove generazioni spesso titubanti di fronte ai dilemmi, o perché non abbastanza edotti dai genitori, oppure intorbiditi o narcotizzati dai mezzi di comunicazione che spesso non danno stimolazione critica. Ecco, la cultura degli anziani è antitetica a quel mondo virtuale in cui ci troviamo immersi e che ci separa dalla vita reale, quotidiana, densa di di difficoltà d’ogni genere.
Se poi gli anziani sono portatori di esperienze manuali, artigianali o d’altro tipo, il gap fra le due generazioni è ancora più evidente, Ah la benedetta manualità che ci mette in contatto con la materia cosiddetta “bruta” ma indispensabile per soddisfare le nostre necessità. L’anziano avendo avuto “la fortuna”, indipendentemente dalla professione che ha esercitato, di eseguire lavori per conto proprio o per conto terzi con l’esercizio delle mani munite di strumenti, ha trasmesso un patrimonio di operatività che nessun altro “maestro” è in grado di comunicare.
Gli anziani sono sono detentori di storie di vita che se accuratamente registrare e interpretate, sono ulteriori tasselli per comporre la storia più ampia di un’intera collettività, oltre naturalmente ai documenti d’archivio che sono sì, importanti, ma restano sempre informazioni prive di pathos, sentimento umano, fantasia e creazione nel rievocare.
Ecco perché la perdita degli anziani in questi tempi calamitosi dell’epidemia, è una tragedia non solo per i familiari, per il sistema sanitario, per la nazione, ma per tutta una cultura fondata sul concreto, il buon senso, l’interscambio quotidiano di pratiche e conoscenze. Si ricorda il famoso pensiero di Leonardo da Vinci: “L’esperienza è il solo insegnante in cui possiamo confidare”.
Mantova, 26 Aprile 2020
TRACKING COVID-19
di Carlo Saletti, storico e regista teatrale
La carta per attraversare questo tempo nuovo e amaro è accessibile sulla rete. Ad averla concepita e a tenerla aggiornata, facendola aderire allo scorrere delle ore, è il Center for Systems Science and Engineering (CSSE) del dipartimento di Ingegneria Civile e dei Sistemi della John Hopkins University di Baltimora.
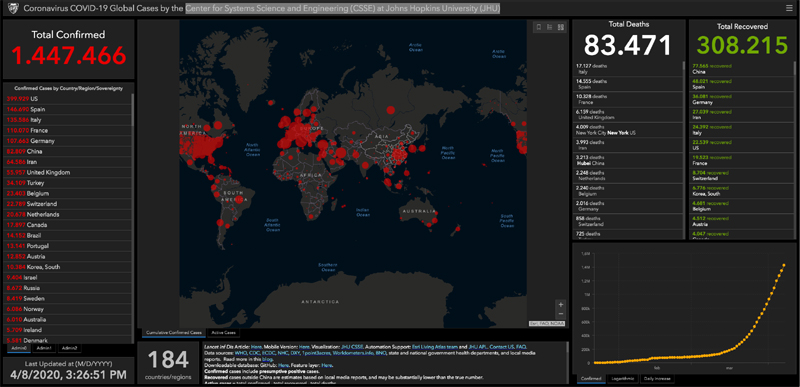
Il tabellone è aggiornato al tempo corrente, a partire dal 22 gennaio 2020.
Tracking COVID-19 è nato per tenere traccia della diffusione mondiale dell’epidemia nel suo evolversi quotidiano. Il cruscotto (dashboard) è suddiviso in tre campi: alla sinistra e alla destra sono elencati i numeri del contagio (casi suddivisi per paese, totale dei deceduti e dei guariti – i sommersi e i salvati), mentre al centro, sul planisfero dinamico, sono indicati attraverso pallini di diverso diametro la presenza del contagio relativamente nelle diverse aree geografiche. Anche se non è l’unico strumento cartografico di monitoraggio complessivo disponibile, Tracking COVID-19 presenta il cruscotto più chiaro e semplice da leggere.

Lauren Gardner, condirettore della CSSE e ideatrice del progetto, ha iniziato la mappatura il 22 gennaio. In un’intervista, ne ha spiegato la genesi: “Abbiamo iniziato a gennaio, quando l’epidemia era praticamente solo in Cina. Il mio studente laureato Ensheng Dong, che è cinese, era personalmente interessato. In poche ore abbiamo realizzato il particolare dashboard. E il giorno successivo, l’ho condiviso su Twitter e è diventato subito popolare”. Gardner, che si era precedentemente impegnata nella modellazione spaziale di epidemie di morbillo e virus Zika, è interamente assorbita nel progetto: “È estenuante. Lo facciamo da gennaio. Abbiamo lasciato cadere tutto il resto in laboratorio. E probabilmente sarà così per almeno un altro paio di mesi. E penso che seguiremo l’epidemia per un anno. Continuerà ad andare avanti e rimbalzare in tutto il mondo”.
Custoza, 9 aprile 2020
TRIAGE
di Luciano Butti, docente di diritto ambientale unipd
In condizioni di emergenza, come scegliere quali pazienti avviare con priorità al trattamento o alla terapia intensiva? A sorpresa, ci potrebbe assistere una “grammatica morale istintiva”.
Nel Tempo del Virus, abbiamo tutti familiarizzato con una parola, Triage.
Questo termine francese, che significa «cernita, smistamento», indica il sistema utilizzato per selezionare i soggetti coinvolti in uno o più infortuni, secondo classi di urgenza crescenti, di norma in base alla gravità delle lesioni riportate (così avviene in periodi normali, per esempio, al Pronto Soccorso).
La decisione delle priorità presenta peraltro risvolti anche etici particolarmente delicati durante eventi catastrofici caratterizzati da afflusso importante di persone bisognose di assistenza. In questi casi, il triage è funzionale a far sì che tutto l’impianto del soccorso funzioni con la maggiore possibile efficienza. In altre parole, può accadere che il triage debba indirizzare le prime risorse disponibili non verso chi è più grave, ma verso chi è meno grave o comunque maggiormente in grado (per età e condizioni generali) di beneficiare del trattamento, e di beneficiarne più a lungo.
Durante l’emergenza in corso, criteri come questi sono stati ribaditi in un documento della Società italiana di anestesia e rianimazione. Significativo il titolo di queste linee guida: Raccomandazioni di etica clinica per l’ammissione a trattamenti intensivi e per la loro sospensione, in condizioni eccezionali di squilibrio tra necessità e risorse disponibili. Raccomandazioni di questa natura richiamano inevitabilmente un dibattito filosofico che ci accompagna e ci intimorisce da secoli: quello fra la filosofia utilitaristica (Bentham) e l’etica deontologica (Kant).
Meno noto è che la filosofia analitica di matrice anglosassone ha formalizzato una serie di esempi e dilemmi nei quali viene chiesto di ‘scegliere’ tra una decisione improntata all’utilitarismo (“lasciar morire uno per salvarne cinque”) e ad una pura etica deontologica (“non agire in alcun modo che possa comportare danno ad una persona”). Si tratta dei famosi “problemi del carrello” (Trolley Problems) inventati circa un secolo fa dalla filosofa Philippa Foot. Ciò che si è notato è che le risposte delle persone ai vari dilemmi non seguono sempre criteri razionali. In altre parole, persone che talora rispondono a determinati dilemmi secondo una regola utilitaristica cambiano approccio filosofico di fronte a dilemmi solo leggermente diversi. Molto interessante e semplice a questo riguardo è il volume di David Edmons Uccideresti l’uomo grasso?

Si è dunque ipotizzata l’esistenza nel nostro cervello di una grammatica morale istintiva (universal moral grammar), che ci consentirebbe, in circostanze eccezionali, di adottare le decisioni giuste. Di questo abbiamo grande necessità durante i Tempi del Virus. Non solo per le decisioni di emergenza relative ai pazienti, ma anche per orientare le progressive decisioni di riapertura: in un indispensabile bilanciamento tra salute, economia e libertà delle persone.
Bibliografia. D. Edmonds, Uccideresti l’uomo grasso. Il dilemma etico del male minore, Raffaello Cortina, Milano, 2014; P.Foot, The Problem of Abortion and the Doctrine of the Double Effect, in “The Oxford Review”, N. 5, 1967;
TUTA
di Michela Zio, giornalista di moda
La tuta, è il capo di abbigliamento più usato nel tempo libero e, dopo il pigiama, è la divisa nel lockdown da coronavirus che rende gli italiani tutti uguali. O quasi.
Comoda e confortevole, la tuta ha origini nella cultura futurista italiana degli anni Venti come indumento eversivo e liberatorio, creato dall’artista fiorentino Ernesto Michahelles, in arte Thayaht che realizzò un “abito universale” in un pezzo solo di cotone o di tela d’Africa semplice, ma rivoluzionario al tempo stesso. Quella “TuTa” (dal francese tout-de-même “tutti uguali”) simbolo della protesta anti-borghese che avrebbe dovuto vestire gli uomini di ogni estrazione sociale. Ma Thayant andò oltre, cercando e trovando nel suo tout-de-même lo spunto per esprimere anche nel nome dell’abito l’immediatezza futurista delle ‘parole in libertà: il modello a forma di T, il busto che disegna la U e la A delle gambe siglò definitivamente l’indumento.

Inutile dire che sulla moda del tempo la tuta non attecchì. Si fece invece largo tra i militari, gli sportivi e gli operai a cavallo tra il primo e il secondo conflitto mondiale, per poi essere usata anche in campo sanitario, grazie a particolari tecnofibre, per poi approdare nel guardaroba delle signore, grazie all’estro degli stilisti, a partire dagli anni Novanta. La tuta è diventata, nel tempo, sinonimo di comfort e ha subito ulteriori evoluzioni diventando un capo di abbigliamento composto da un pantalone e una felpa di solito chiusa da zip, con o senza cappuccio e tasca marsupio utilizzato dagli sportivi e nella moda casual dalla metà degli anni Ottanta con l’avvento della breakdance e dell’hip hop.
Dagli anni Novanta in poi la tuta è elemento-moda ricorrente nel look di molte star da Manhattan a Los Angeles da Londra a Parigi, da Shangai a Milano: Madonna, Geri Halliwell, Britney Spears, Jennifer Lopez per citarne alcune hanno sfoggiato in molte occasioni i pantaloni della tuta sotto la giacca smoking e con eleganti tacchi a spillo.
Torino, 2 aprile 2020
TUTTO ANDRA’ BENE
di Marta Alberti, filosofa
Da quando, ai primi di Marzo, abbiamo cominciato ad avvertire la gravità della minaccia che l’epidemia di coronavirus inavvertitamente aveva portato anche in Italia, il web, i canali social e le facciate dei palazzi sono stati invasi da queste tre parole. Al solito, i mezzi di comunicazione hanno trasformato un gesto, probabilmente spontaneo, in un fenomeno virale (a proposito) ma gli autori dei tanti disegni, striscioni e a volte piccoli murales sono soprattutto bambini. Portatori sani del virus, ci viene detto, ma anche portatori sani di speranza. E la speranza è l’ultima a morire. Non a caso, è una virtù che accomuna i più semplici di spirito: i bambini e i mistici. Basta una veloce ricerca per scoprire che: “All shall be well” è la benedizione che la mistica Giuliana di Norwich, ammalatasi di peste nel 1373, raccontò di avere ascoltato direttamente da Dio grazie ad una visione ricevuta durante la sua quarantena.

La rivelazione per Giuliana fu immediata ma, anche una volta guarita, attese quasi trent’anni prima di renderla pubblica. Qui sta la distanza infinita tra lo slogan e la verità intima: il primo contagia molti e perde forza proprio per effetto della sua diffusione fulminea e pervasiva (i virus fanno così); la seconda può sorgere dentro di noi quasi a nostra insaputa e continua a dimorare nell’interiorità prendendo forma e sostanza perché custodita e rivisitata ogni giorno, condivisa innanzitutto con se stessi e mai indiscriminatamente. L’intimità è un luogo fatto di silenzio e profondo rispetto per se stessi. “Tutto andrà bene” può suonare come la magra consolazione per sorvolare con ingenuità sui tempi difficili oppure come la radicata convinzione che, nonostante tutto e al di là della nostra volontà, ciò che viviamo ci riconduce sempre a qualcosa di profondamente vero. Due significati ben diversi, eppure, le parole sono le stesse.
Verona, 26 marzo 2020
Bibliografia. Vannini Marco, Lessico mistico. Le parole della saggezza, Le Lettere, Firenze 2013,
VELOCITA’
di Pierluigi Tregnaghi, medico sportivo
La velocità è una delle qualità fondamentali per emergere nel mondo dello sport. Se restringiamo il campo, a scopo esemplificativo, ad una specialità molto praticata dell’atletica leggera come la maratona, si possono abbozzare dei parallelismi interessanti con la situazione emergenziale attuale legata al Coronavirus. Lo stile di corsa di un maratoneta può essere bello quanto si vuole, ma per poter centrare un buon piazzamento, anche a livello amatoriale, vanno coniugate insieme la preparazione fisica con l’aspetto mentale. Per sviluppare la prima è necessaria una programmazione negli allenamenti, mentre il secondo si costruisce progressivamente con l’esperienza accumulata sul campo. Il fattore mentale, secondo molti podisti, è un connotato fondamentale nel contrastare la fatica, costituisce, infatti, una sorta di cabina di regia che guida e motiva la prestazione.

Davanti all’evento emergenziale come l’attuale pandemia, la velocità delle nostre azioni, del nostro fare e rifare, del contemporaneo incastro di molte incombenze nello spazio di un tempo tiranno, ha subito una brusca frenata. Invece, è lievitata di molto la resistenza mentale per fronteggiare le restrizioni, che hanno confinato le nostre quotidiane azioni in spazi più angusti e tempi a disposizione più dilatati. La lentezza, l’esatto contrario della velocità, viene ora rivalutata e ce la troviamo a portata di mano, senza crearla artificialmente, come un benefico stato psicologico interiore da sperimentare in relazione alle persone che ci circondano. La corsa frenetica a cui assistiamo oggi è quella delle autoambulanze che solcano sparate le direttrici verso i due ospedali della città, dove la velocità di intervento e la resistenza mentale dei nostri sanitari impegnati nell’emergenza si saldano insieme, da settimane, in un connubio virtuoso. Sono loro i nostri maratoneti al tempo del coronavirus.
Colognola ai Colli (VR), 11 aprile 2020
VACCINO
di Stefano Adami e Laura Celesti, GSK Vaccini
La specie umana si misura da millenni con i “microbi” (batteri, virus, parassiti) e con la forza distruttrice delle malattie infettive come, ad esempio, la peste della metà del 1300 o la “Spagnola” del 1918-20 che si sono diffuse in modo veloce e irruente lasciandosi alle spalle cumuli di macerie umane. Altri agenti patogeni si diffondono magari più lentamente ma hanno effetti altrettanto pesanti, come il virus HIV dell’AIDS che da circa trent’anni imperversa nel mondo. A queste tremende epidemie la scienza ha saputo far fronte, ad esempio con la produzione di vaccini, strumenti al servizio della medicina che negli ultimi cento anni hanno evitato malattie a generazioni di abitanti, in particolare dei paesi occidentali.
La parola vaccino, che in ordine alfabetico sta poco sopra all’altra ben più temuta virus e a cui inevitabilmente viene associata, é tornata prepotentemente alla ribalta: mai come in questi giorni infatti se ne sente parlare. Per il vaccino che verrà, contro il Coronavirus, in molti fanno il tifo, speranzosi e fiduciosi, vedendolo come una panacea sociale e economica e una barriera contro la paura, che possa risolvere una volta per tutte la drammatica situazione pandemica contro la quale il mondo improvvisamente si é trovato a combattere. Certo non mancano anche oggi, come si può vedere scorrendo vari siti Internet, coloro che continuano a rilanciare tesi complottistiche sull’origine del Coronavirus, notizie false e quindi contrarie all’utilizzo dei vaccini. Tutti ricordiamo le discussioni di alcuni mesi fa sugli obblighi vaccinali richiesti dalla sanità pubblica ma invisi a molti e la sequela di contestazioni e fake news che si portavano dietro. Ovunque sui media in questi giorni si parla di molecole, recettori, sperimentazione, messa a punto del vaccino, prove su animali, studi clinici sull’uomo… Un intero mondo, fino ad ieri confinato alle discussioni tra scienziati, virologi e immunologi.
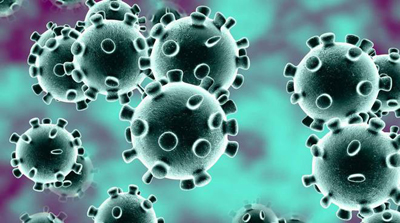
Che cosa è un vaccino? Tecnicamente, il vaccino é un preparato biologico costituito da virus uccisi o attenuati, o da loro porzioni o da sostanze prodotte dai microorganismi stessi e rese sicure o anche da loro proteine ottenute con tecniche di ingegneria genetica. Una volta somministrati, i vaccini simulano il primo contatto con l’agente infettivo, evocando una risposta immunologica simile a quella causata dall’infezione naturale, senza però causare la malattia. Attraverso i vaccini, quindi, il nostro sistema immunitario impara a riconoscere il nostro nemico (l’agente patogeno) molto prima di venirne in contatto, in modo che, quando questo dovesse succedere, il nostro organismo reagisca immediatamente, bloccandone la replicazione fin dalle prime fasi e impedendo lo sviluppo della malattia.
Come si produce un vaccino? Non esiste un unico metodo, dipende dal nemico da combattere che deve essere conosciuto e studito moltobene. In generale si può dire che il nostro “piccolo mostro” innanzittutto deve esser fatto sviluppare su un idoneo terreno colturale e poi inattivato per impedire che sia nocivo. Successivamente si deve isolare la struttura identificata come quella che stimola meglio il nostro sistema immunitario; questa fase “grezza” del vaccino deve essere purificata, eliminando quello che non serve (ad esempio residui del terreno di coltura o del “veleno” utilizzato per inattivarlo) ed infine resa sterile mediante un processo di filtrazione. A questo punto il vaccino concentrato viene diluito fino alla concentrazione ottimale, eventualmente addizionato di “adiuvanti” che ne facilitano l’azione, ripartito in flaconi o siringhe e confezionato. Prima della distribuizione sul mercato ogni lotto di vaccino viene controllato dal punto di vista qualitativo per dimostrarne, attraverso opportuni test, la sterilità, l’efficacia, la purezza e la stabilità nel tempo. Solo allora può essere utilizzato per la vaccinazione.

Tutto questo processo necessita di molto tempo, di mesi se non anni … Immaginiamo soprattutto se si deve partire da zero per cercare un nuovo vaccino per un virus ancora parzialmente sconosciuto: i passaggi sopra elencati devono essere prima individuati e poi confermati con un certo numero di prove, come previsto dai protocolli sanitari, condotte su animali e sull’uomo. Un tempo di dodici mesi per avere un nuovo vaccino é quindi una previsione piuttosto ottimistica; una possibile soluzione per ottimizzare i tempi sarebbe quella di creare una cordata planetaria di scienziati e produttori che collaborino tutti insieme per lo sviluppo e la commercializzazione del vaccino. Qualcosa del genere è già successo, in passato, ad esempio per il vaccino contro la poliomielite: Chissà se, in questo momento di drammatica crisi, riusciremo ad essere altrettanto saggi, generosi e disinteressati.
Volto e vaiolo (il)
Pensée, Pascal (Laf.688, Sel.567)
di Daniele Capuano, studioso di ebraismo e islam
Una delle molte pensées di Blaise Pascal che non si dimenticano inizia con la domanda delle domande: “Che cos’è l’io?”. L’indagine prende subito un abbrivo scettico: “Un uomo che si mette alla finestra per vedere i passanti; se io passo di là, posso dire che si è messo là per vedermi? No, perché non pensa a me in particolare”. Senza l’intervento di attenzione e memoria, ciò che entra nel campo percettivo, nella “finestra”, non è un “qualcuno”, una sostanza individuale, ma un oggetto fra i molti, un lineamento del paesaggio. “Ma chi ama qualcuno a causa della sua bellezza, ama lui? No, perché il vaiolo, che ucciderà la bellezza senza uccidere la persona, farà in modo che non l’ami più”. Non possiamo dire di amare “qualcuno”: lo amiamo ad esempio per la bellezza del volto (e in realtà dunque amiamo il bel volto), che il vaiolo (la petite vérole) può sfigurare, “uccidere”. Sorge l’obiezione sentimentale: ma si ama davvero l’interiorità, ciò che non si vede e non si tocca; ed è qui che cala il fendente più affilato. Vale infatti, e in modo ancor più preoccupante per il nostro senso d’identità, lo stesso principio: amiamo non qualcuno in quanto tale, ma per la sua memoria, il suo intelletto; amiamo qualità, anche qui, che come la bellezza possono essere “uccise” da altri vaioli, da altre pesti (neurologiche, psichiatriche) – e infine, le une e le altre, le visibili e le invisibili, dalla morte. Pascal conclude: “non si ama dunque mai qualcuno (personne), ma solo delle qualità”.
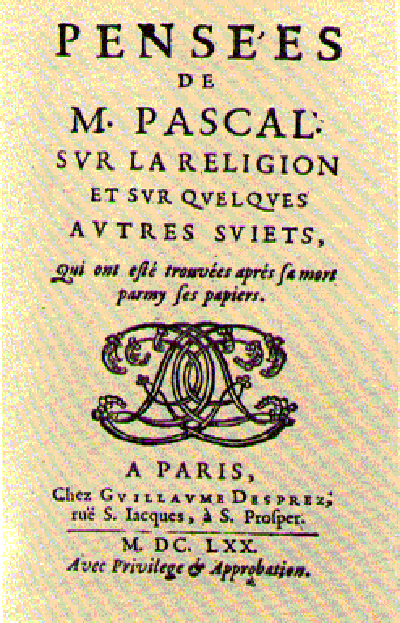
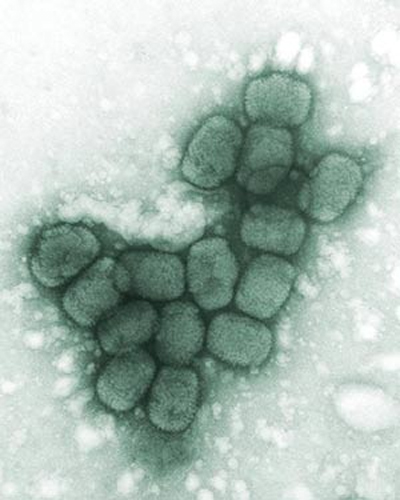
Il vaiolo, infezione endemica in quasi tutti i paesi della Terra fino a pochi decenni or sono, è qui – come altrove la peste – un particolare promosso a immagine potente dell’universale: il volto, ogni volto, anche se non sfigurato è sfigurabile, come – e perché – ogni organismo vivente è mortale. Ma se l’io non può essere conosciuto e amato, se non può essere, in quanto tale, oggetto di conoscenza e amore, perché è (o dovrebbe essere) il soggetto, ne segue davvero che possiamo amare e conoscere solo qualità temporanee, fenomeni impermanenti, parvenze minacciate – oggetti? L’io che qui Pascal dichiara inafferrabile, e in un’altra famosa pensée “degno d’odio”, non si rifugia così nell’ombra da dove dichiara di poter amare e conoscere solo qualità? Ma è proprio vero? Non sarà che, come non possiamo amare qualcuno, così neanche qualcosa? Il vaiolo che sfregia il volto amato, il morbo che sfregia il bel volto della donna, della città, del mondo, è una rivelazione, una apocalissi intima e pubblica: possiamo credere di disamorarci, perché abbiamo amato (creduto di amare) qualcosa; possiamo credere di amare la “sostanza, l’anima” in astratto, e Pascal dice che sarebbe “ingiusto”: o possiamo lasciare che la petite vérole ci mostri, oltre all’introvabilità del moi, dell’io, anche quella delle sue proiezioni, dei suoi correlativi inseparabili. Come insegnava Dylan Thomas al figlio, “tutte le tue azioni e parole,/ ogni verità, ogni menzogna,/ muoiono nell’amore che non giudica”: se morirvi è davvero un morire.
Il bel volto desiderato, che il vaiolo ha ricoperto di una maschera permanente, sembra un’immagine lontana dalle devastazioni operate ai nostri giorni dal COVID-19, che aggredisce invisibilmente i polmoni e uccide nel silenzio dell’asepsi e delle macchine i corpi e le anime, e induce a rinnovare in modo ancora imprevedibile i foucaultiani dispositivi, creduti superati, del confinamento e del quadrillage: eppure entrambe le catastrofi sollecitano le domande essenziali, le domande su cosa muore e cosa resta, su cosa fonda la convivenza, il desiderio e l’amore, l’io e l’altro. Il frammento pascaliano ci soccorre perché, formulandole in modo esatto e spietato, custodisce il nucleo della risposta che, per soddisfarci, non potrà mai essere – se non indirettamente – formulabile.
Roma, 6 aprile 2020.
Viaggio intorno alla mia camera
di Carlo Saletti, storico e regista teatrale
Xavier de Maistre – nato a Chambéry nel 1763 nell’alta Savoia (regione all’epoca appartenente al Regno di Sardegna) e fratello minore del più noto Joseph – è l’autore del romanzo Voyage autour de ma chambre, scritto nel 1787. Dovendo scontare 42 giorni agli arresti domiciliari nel proprio alloggio a Torino per aver sfidato a duello un commilitone, De Maistre si convinse ben presto che scrivendo avrebbe vinto la noia per la forzata cattività. La costrizione fu così all’origine di un libro che costituisce una sbalorditiva opera sul viaggio sedentario.
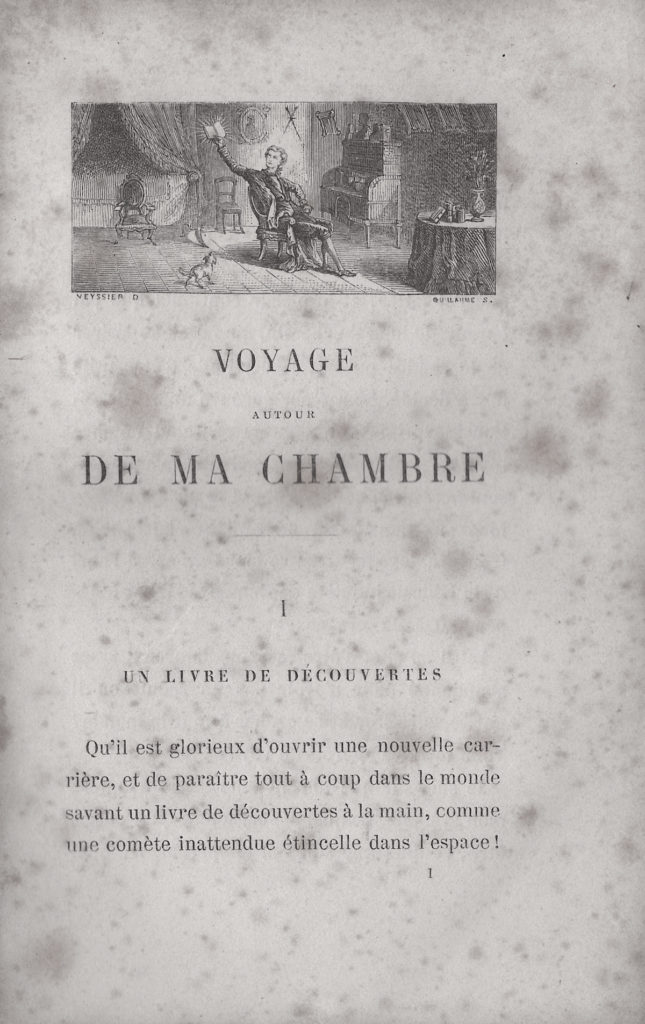
apparsa a Parigi nel 1861.

del libro di De Maistre.
Ma per parlare di un spostamento nello spazio occorre prima averlo compiuto. Come fare, quando l’orizzonte è chiuso da pareti invalicabili? De Maistre non si perde d’animo e, affidandosi ai soli piedi, parte alla scoperta dell’inesauribile spazio della stanza, iniziando a misurarne l’estensione: “La mia camera è situata sotto il quarantesimo giorno di latitudine, fra levante e ponente; è forma un lungo quadrato, di trentasei passi in tutto, andando ben rasente rasente le pareti dell’interno. Dopo la mia seggiola a braccioli andando verso il settentrione si scopre il mio letto, che è posto in fondo alla mia camera”. Egli pianifica un metodo e si assegna delle regole – procederà senza seguire una traiettoria lineare: “La traverserò [la camera] spesso in lungo e in largo, ovvero diagonalmente senza seguire metodo o regola. Andrò anche a onde, e percorrerò tutte le linee possibili in geometria, ove il bisogno lo richiegga”. Arriva finalmente il momento della partenza: “Coraggio, dunque, si parta. Noi procederemo a picciole giornate. Nessun ostacolo potrà arrestarci.”
Quattro metri per quattro è la superficie della regione che egli esplora in 42 giorni, quantità di tempo che rappresenta la misura della pena che deve scontare. Una tappa al giorno, un capitolo al giorno, il viaggio dura quanto la sua quarantena.
De Maistre aveva dimostrato che con poco si poteva fare molto, come avrebbe osservato Nietzsche, quando lesse rapito quell’insolito diario di viaggio.
Custoza, 24 marzo 2020
Bibliografia. Xavier de Maistre, Viaggio attorno alla mia camera, Manini, Milano, 1824; Alain De Button, L’arte di viaggiare, Guanda, Milano, 2002.
VULNERABILITA’
di Olivia Guaraldo, docente di filosofia politica univr
L’umano è essenzialmente un essere vulnerabile, dice una interessante prospettiva filosofica recente, di matrice femminista. E ciò significa che siamo tutti da sempre costitutivamente esposti gli uni alla ferita (vulnus), alla violenza degli altri. Si tratta di uno sguardo radicale, che prende le mosse da una ‘ontologia’ materiale del corporeo, difficilmente negabile, la quale scalza, con il piglio teorico audace proprio di certo pensiero femminista, le versioni ‘nobili’ che la filosofia (maschile) ha si dall’inizio dato dell’anthropos (l’uomo come animale razionale è l’esempio aristotelico classico). Ma lo fa al fine di ripensare la convivenza umana in chiave nonviolenta. Siamo tutte e tutti accomunati se non da una uguaglianza di condizione vulnerabile (ci sono, ovviamente, diversi gradi di esposizione alla ferita, a seconda dei luoghi del pianeta in cui si vive) da una somiglianza nella vulnerabilità. Per questo dobbiamo ripensare la nostra comune convivenza, non fingendoci invulnerabili o pensandoci tali al prezzo di una costante vulnerazione di altri. Che l’umano sia vulnerabile significa infatti anche che può non esserlo, o meglio, che nella potenziale esposizione alla ferita altrui (alla sua violenza) è insita anche la possibilità del non ferire, o del curare.
La nostra comune vulnerabilità è ai tempi del coronavirus quanto mai innegabile, eppure non si tratta qui né di violenza né di etica nonviolenta. L’esperienza attuale ci pone di fronte ad una nuova accezione della vulnerabilità: essa non richiama in maniera immediata la ferita, la lacerazione della carne propria di una violenza intraspecifica a cui la storia, con il suo vasto archivio di guerre, massacri, genocidi, ci ha abituato. Non vediamo sangue o teste mozzate, ma solo mascherine e respiratori in questa nuova ‘guerra’ contro il virus. Eppure, oggi più che mai, si rivela vero lo sguardo audace di una filosofia che ci ricorda quanto siamo vulnerabili, esposti ad una relazionalità corporea oggi materializzata in quelle goccioline di respiro da cui spesso dipende, così si racconta, il contagio. Un contagio che viene da un altro corpo, da un altro essere incarnato, trasudante vita, il quale però non è un nemico, ma l’inconsapevole asintomatico. Che fare dunque di una vulnerabilità senza la violenza, senza l’atto consapevole della ferita?
Se c’è un elemento che rimane prezioso della prospettiva filosofica sulla vulnerabilità, oggi, è la consapevolezza, mai così forte, di una dimensione di somiglianza e quindi di comunanza. E tale occasione, forse mai nella storia umana esperibile in maniera così uniforme, ci pone di fronte alla possibilità di praticare una forma innovativa di ‘cura’ per gli altri: una cura che si basa non sull’accentuazione della relazione, ma su una sua sospensione. Alla percezione diffusa della nostra somiglianza nella vulnerabilità rispondiamo prendendoci cura gli uni degli altri allontanandoci. Perché ciascuno di noi può essere l’inconsapevole asintomatico, il nemico malgré soi.

Dice Aristotele: “le madri gioiscono d’amare: alcune infatti danno le loro creature a balia e le amano conoscendo che sono loro creature e non cercano di essere ricambiate nell’amore, se entrambe le cose non sono possibili, ma a loro sembra che sia sufficiente vedere che agiscono bene; ed esse li amano anche se i figli non tributano nulla di ciò che si deve ad una madre, poiché non le conoscono. (Etica Nicomachea, 1159a 28).
Dobbiamo fare, o forse facciamo, come quelle madri descritte da Aristotele – stranamente sensibile in questo caso alla specificità del femminile – che amano i figli rimanendo da loro lontane, non pretendendo nulla in cambio se non, appunto, il bene di quegli stessi figli. Una forma inedita di cura (l’assenza di contatti per non essere involontari diffusori del virus) che ha però radici antiche. Impariamo dalle madri, a capire quanto dipendiamo, in forme relazionali molto diverse fra loro, gli uni dagli altri.
Caprino Veronese, 26 marzo 2020
Bibliografia. Judith Butler, Vite precarie. I poteri del lutto e della violenza, Postmediabooks, Milano, 2012; Adriana Cavarero, Orrorismo, ovvero della violenza sull’inerme, Feltrinelli, Milano, 2007; Olivia Guaraldo, Comunità e vulnerabilità, ETS, Pisa, 2012.
di Costantino Di Sante, storico
ZONA ROSSA
di Costantino Di Sante, storico
La prima volta che ho sentito parlare di “zona rossa” è stato in occasione del G8 di Genova. Nel capoluogo ligure il club dei Paesi ricchi si erano dati appuntamento per aspirare a diventare “governo dell’economia mondiale”. Per salvaguardare “l’incolumità dei grandi della terra”, la città ligure era stata divisa in “zona gialla” ad accesso limitato e “zona rossa” accessibile in pochi varchi ai solo residenti. La Fortezza Genova fu delimitata da grate e container per impedire, a chi riteneva la “zona rossa” illegittima ed una grave limitazione delle libertà costituzionali, di potervi entrare.
Tra il 19 e il 22 luglio del 2001 oltre 700 associazioni della galassia no global, o alter global, si ritrovarono a Genova per manifestare contro il modello di globalizzazione che si stava costruendo e rivendicando il diritto di influire sulle regole del gioco del commercio mondiale. Del G8 di Genova e della sua “zona rossa”, nella memoria collettiva rimane l’arbitraria sospensione, da parte del governo dell’epoca, dei diritti costituzionali con: le devastazioni, l’uccisione del giovane Carlo Giuliani (20 luglio), il vergognoso pestaggio notturno da parte della polizia dei dimostranti alla caserma Diaz (21 luglio), le torture e le violenze avvenute nella caserma di Bolzaneto.


nel 1916 nella Zone Rouge.
Foto di John Warwick Brooke – Imperial War Museums
Nel nostro Paese si è poi tornati a parlare di “zona rossa” dopo il terremoto dell’Aquila del 6 aprile 2009. Nella città abruzzese e in altre frazioni, furono istituite delle “zone rosse” dove, per ragioni di sicurezza, era precluso l’accesso anche ai residenti. Ancora oggi ci sono parti del capoluogo abruzzese e di alcune frazioni che non sono state ancora messe in sicurezza. In queste aree, definite ancora “zona rossa”, per entrarci c’è bisogno di redigere un apposito modulo. Anche dopo gli ultimi terremoti, che più di tre anni fa colpirono Amatrice e molte località del Lazio, delle Marche, dell’Umbria e dell’Abruzzo, si è applicato lo stesso criterio.
Il termine ha origini militari e il suo utilizzo, non a caso, serve per indicare un luogo soggetto a divieti e vincoli, che possono essere anche temporanei, perché minacciato da forti rischi, siano essi ambientali, sociali o di altra natura. La Zone rouge, per la prima volta fu utilizzata nel 1919 quando, dopo la prima guerra mondiale, il governo francese espropriò i territori a nord est della Francia: Circa 1.200 chilometri quadrati furono interdetti perché il suolo di questa vasta area erano stati sfregiati dalle intense e devastanti battaglie che vi si consumarono (Verdun, Somme), contaminati da aggressivi chimici, da ordigni inesplosi e sepolti nel sottosuolo. Ancora oggi questi luoghi sono inabitabili e privi di vita, con i terreni deturpati e con la vegetazione completamente scomparsa. Si calcola che ci vorranno ancora 700 anni per bonificarli completamente.
Un’altra “zona rossa”, legata a disastri ambientali, è l’area di 30 km più contaminata dalle radiazioni vicino all’ex centrale nucleare di Chernobyl. Così viene indicata la zona. Questo è l’anello più piccolo (detto anche Exclusion zone o Quarta zona) dei quattro che compongono la Zona di alienazione. Istituita dal governo sovietico, per poter evacuare la popolazione e per impedirne il loro ritorno dopo il disastro nucleare del 26 aprile 1986, ancora oggi è uno spazio interdetto e controllato dalle forze speciali dell’esercito ucraino. Nell’area dichiarata ancora ufficialmente contaminata, vivono cinque milioni di persone con un’alta percentuale di patologie, tra le quali infertilità e malformazioni. Nella “zona”, nonostante gli alti livelli di radiazioni, vi possono entrare gli addetti che vi lavorano per tempi prestabiliti. Inoltre, da alcuni anni, è possibile entrarvi per brevi visite di un giorno organizzate da tour operator di Kiev.
Nel nostro Paese esiste una “zona rossa”, oramai permanente, quella del Vesuvio. Questa riguarda un territorio in cui abitano 700.000 mila persone e coinvolge 25 comuni. La forte antropizzazione alimentata dalla scellerata urbanizzazione sviluppatasi nel dopoguerra, fa sì che oggi il Vesuvio sia considerato il vulcano più pericoloso al mondo visto anche che i piani di evacuazione efficienti ritardano ad essere elaborati.
L’attuale minaccia del Covid-19 ha comportato che molti stati abbiano istituito o dichiarato tutto il Paese “zona rossa”. Ricordiamo che ad applicare questa misura per la prima volta, 23 gennaio 2020, è stata la città cinese di Wuhan, da dove il virus si è generato. L’Italia è stato il secondo Paese dove sia stata costituita una “zona rossa”. Era il 22 febbraio quando Codogno e altri 10 comuni sono stati isolati dal resto del mondo. All’epoca era quasi impensabile che, dopo poche settimane (10 marzo), tutta l’Italia sarebbe diventata “zona rossa”.
Campli , 8 aprile 2020
Bibliografia: D. De Sousa, La Reconstruction et sa Mémoire dans les villages de la Somme 1918–1932, Editions La vague verte, Mortagne-au-Perche 2002; Sito della Protezione civile dedicato al rischio Vesuvio, su protezionecivile.it, A. Nazzaro, Il Vesuvio: storia eruttiva e teorie vulcanologiche, Liguori, Napoli 2001; G.U. Medvedev, Dentro Chernobyl. La vera storia della catastrofe che ha sconvolto il mondo, Edizioni la Meridiana – Legambiente, Molfetta (Ba) 1996; A. Higginbotham, Mezzanotte a Cernobyl. La storia mai raccontata del più grande disastro nucleare del XX secolo, Mondadori, Milano 2019; UN plots Chernobyl zone recovery (http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7105273.stm), BBC news, Nov 21, 2007; M. Ferraris, I silenzi della zona rossa G8 e dintorni, Fratelli Frilli Editori, Genova 2001; G. Chiesa, G8/Genova, Einaudi, Torino 2001; www.prefettura.it/lodi/news/…dpcm_23…nella_zona_rossa-8410962.htm.
ZOONOSI
di Marco Tabacchini, PhD Scienze umane Univr
Nel suo recente Spillover. Animal Infections and the Next Human Pandemic, David Quammen definisce come zoonosi «ogni infezione animale trasmissibile agli esseri umani»: si tratta di malattie dovute a microorganismi patogeni – virus, batteri, funghi, prioni, vermi e protisti – un tempo endemici in animali non umani ed evolutisi al punto da compiere un salto oltre i confini di specie, destabilizzandone i rassicuranti contorni.
Zoonosi è un termine ad alta densità, in cui confluiscono anzitutto saperi medici e biologici, ma anche quelli legati all’ecologia e all’antropologia, fino a toccare tutto il campo delle discipline complesse che tentano di avvicinare la molteplicità dei viventi. Anche le scienze politiche ne sono chiamate in causa, là dove, di fronte a
una pandemia in atto, finiscono per esprimersi sulle modalità per coniugare la sicurezza e il governo dei corpi (due obiettivi necessari eppure impossibili). Non ne è estranea nemmeno la mitologia, se è bastato affiancare l’origine animale del coronavirus Covid-19, ipotizzata in chirotteri e pangolini, alle usanze culinarie cinesi per confezionare una nuova veste alla ricerca di capri espiatori.
In quanto zoonosi, l’attuale pandemia presenta affinità con molte altre malattie dovute a un patogeno riuscito a radicarsi nell’organismo umano solo dopo aver utilizzato come serbatoio animali infetti di altre specie: con la rabbia, con la storica peste bubbonica e la “spagnola” di inizio Novecento, ma anche con virus dai nomi esotici quali Ebola, Nipah o Hendra, tutti legati a più recenti salti di specie (spillover). Di origine zoonotica è anche l’AIDS, il quale, prima di trasferirsi nell’uomo e colpire milioni di individui, aveva trovato nelle scimmie antropomorfe il proprio ospite privilegiato. In Italia il termine “zoonosi” cominciò a circolare già dal 2001, assieme ai primi casi di encefalopatia spongiforme trasmissibili all’uomo dai bovini (la cosiddetta “mucca pazza”): un evento che dimostrò inesorabilmente come la salute dell’uomo fosse strettamente annodata a quella degli animali suoi compagni.
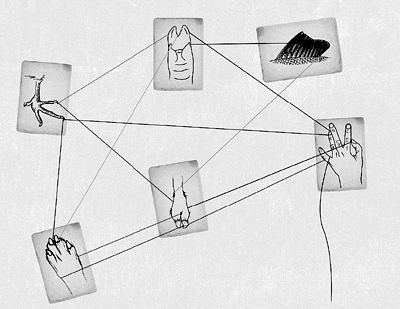
Proprio per tale motivo, e nonostante la parvenza escludente, carica di eccezionalismo umano, che tale termine sembra recare con sé, sono proprio le zoonosi ad aver inequivocabilmente dimostrato che uomo e animale non costituiscono affatto due opposti, né tantomeno due polarità di uno spettro che può essere pericolosamente accorciato con un salto di specie: sono piuttosto due termini con cui classifichiamo, seppur maldestramente, regioni porose di un medesimo ecosistema, nel quale forme di vita e agenti patogeni transitano da un punto all’altro, infischiandosi bellamente tanto dei nostri principi di identità quanto delle nostre logiche binarie. E se, come ha recentemente ricordato Donna Haraway, «Le specie compagnie si infettano a vicenda», l’incontro globale con SARS-CoV-2, e l’esperienza di un virus che ha saputo attraversare i confini di specie e le opposizioni tra umani e non umani, spinge pertanto in direzione di un ripensamento della nostra esistenza in relazione alle altre specie viventi, ossia in relazione alle imprevedibili alterità che
tuttavia non cessano di ibridarsi con noi.
In altri termini, l’esistenza delle zoonosi confermano quella che secondo Quammen è «l’antica verità darwiniana (la più sinistra tra quelle da lui enunciate, ben nota eppure sistematicamente dimenticata): siamo davvero una specie animale, legata in modo indissolubile alle altre, nelle nostre origini, nella nostra evoluzione, in salute e in malattia». E proprio in quanto primati relativamente giovani, molte delle malattie umane e ben oltre il 60 per cento delle nuove malattie emergenti sono in realtà ereditate da altre creature. Un’eredità talvolta ingombrante da sopportare, soprattutto quando essa si manifesta sotto i terribili tratti di nuove e insolite malattie, comparse repentinamente in seno ad altrettanto insoliti intrecci ecologici, ossia là dove nuove specie finiscono per trovarsi, talvolta loro malgrado, compagne di vita e di morte.
Verona, 20 maggio 2020
Bibliografia.: David Quammen, Spillover. L’evoluzione delle pandemie, Adelphi, Milano 2014;
Donna Haraway, Chtulucene. Sopravvivere su un pianeta infetto, NERO, Roma 2019.

